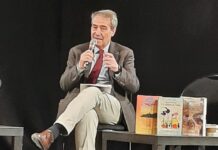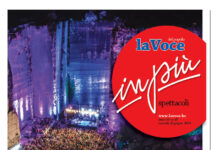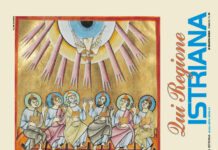Si è tenuta a Trieste una sessione del Forum Tomizza 2024, presso “la sala multimediale che darà vita a LETS, il Museo della letteratura, in cui si perpetua la memoria degli scrittori triestini”, come ha ricordato Riccardo Cepak, che ha portato in apertura i saluti dell’amministrazione comunale della Città. Presente Milan Rakovac, uno degli ispiratori del Forum. Il confronto ha avuto come titolo la “Grammatica dell’oblio”.
L’intervento cruciale è stato quello dell’antropologa di Capodistria, Katja Hrobat Virloget, che ha esplorato come l’oblio non sia assenza di memoria, ma la sua censura. “Non tutto l’oblio è minaccioso, repressivo; può anche essere un mezzo che permette la sopravvivenza, non so tuttavia, se possa essere liberatorio”. La studiosa ha parlato di esplorazione razionale del silenzio. “Il silenzio, in quanto espressione di qualcosa di assente, viene vissuto come qualcosa di fortemente presente. È un mistero, un fantasma che si insinua nell’inconscio dei bambini, trasmettendogli così il passato dei suoi genitori, che lui stesso non ha mai vissuto, il ‘non voler sapere’ è una strategia difensiva”.
La rimozione del ricordo
Tutto questo Katja Hrobat Virloget l’ha osservato tra gli esuli e gli sloveni di Prosecco, frazione di Trieste in cui convivono i due gruppi, durante una ricerca. Il medesimo fenomeno è stato studiato durante un laboratorio a Isola, quando indagando sullo svuotamento dopo l’esodo gli anziani del paese si sono ribellati non volendo ricordare. “Come scrive Primo Levi, ‘chi è ferito rimuove il ricordo per non rinnovare il dolore’, anche se è un oblio indimenticabile. Nel nostro ambiente di frontiera, saturo di ferite collettive, la memoria è strumentalizzata politicamente e ancor oggi, invece di percorrere la strada della riconciliazione, si compete su chi sia la vittima maggiore”, ha concluso l’antropologa.
“Il peso dei traumi di queste zone di frontiera diventano mito e costruiscono stereotipi, ha ricordato Silvia Zetto Cassano, insegnante e scrittrice, nata a Capodistria e vissuta a Trieste dopo l’esodo. Ed è così che il mito ha la meglio sulla costruzione storica. I morti sui vivi, mentre i giovani non ne vogliono sapere”.
Il silenzio come salvezza
Un altro aspetto è stato affrontato da Borut Klabjan, docente universitario e consulente scientifico per il progetto Open borders di Capodistria, quello del “silenzio che permette di non identificarsi in un contesto multilingue, quando è proprio la lingua che ci identifica”. Ha raccontato di un giovane di lingua slovena che davanti all’incendio del Narodni Dom di Trieste preferì tacere davanti a coloro che inneggiavano all’accaduto. Ha concluso l’incontro, moderato da Martin Lissiach, il giornalista Stefano Lusa il quale ha affermato che il 10 febbraio (Giorno del Ricordo) e il 15 settembre (festa del litorale sloveno – annessione alla Repubblica Socialista di Slovenia del territorio, già parte della Venezia Giulia e d’Italia) fanno parte del teatrino della politica. “C’è bisogno di una memoria completa e soprattutto di programmare il futuro, un futuro assieme”.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.