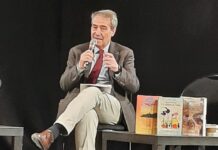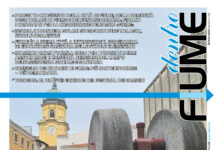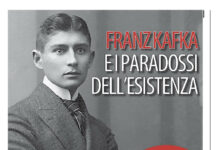Tra gli utensili diventati obsoleti ma che ancora simboleggiano la professione, questa volta parliamo del tastevin ovvero del piattino al collo dei sommelier.
Per molti quello del sommelier è ancora come un mestiere di nicchia che maneggia degli utensili poco conosciuti. Tutti ci destreggiamo con cavatappi e bicchieri (anche se spesso siamo incerti su quale sia il giusto bicchiere da abbinare a un vino); ma la sciabola? Chi l’ha mai vista in azione? Ed è lo stesso per i tastevin che molti hanno visto ma pochi sanno come si chiama. È un oggetto che non passa inosservato e, a vederlo appeso alla pesante catena, sembra un medaglione la cui vistosità e pacchianeria ricorda un playboy da riviera.
Eppure è un oggetto intelligente, pensato e realizzato in modo tale per cui ogni dettaglio ha la sua funzione. Siccome è uno strumento che nasce per necessità, si affina molto presto e condensa in poco spazio tutto quanto è necessario, al massimo della precisione.
Il tastevin apparve intorno al XIV secolo, quando la produzione del vino francese si stava ancora sviluppando, ma già emergevano tre zone in particolare, la Borgogna e lo Champagne al nord e il Bordeaux nella fascia centro-occidentale. La produzione del vino era limitata e promossa principalmente dagli ordini monastici per i loro bisogni liturgici. Il vino francese veniva considerato adatto solo al consumo locale, perché a corte gli si preferivano i vini “più pregiati” del Mediterraneo, soprattutto orientale, commercializzati dai veneziani.
Ben presto però ebbe inizio una forte rivalità tra le varie regioni vinicole francesi per assicurarsi i favori della tavola reale e della nobiltà, che avrebbero garantito il successo commerciale. Quest’intensa concorrenza sfociò nella “battaglia dei vini” che continuò per diversi secoli, durante i quali i viticoltori cercavano freneticamente di ottenere premi e riconoscimenti per i propri prodotti, affinandoli, migliorandoli e cercando in tutti i modi di metterli in risalto (l’odierna superiorità dei vini francesi, deve molto a quel periodo).
Da questo contesto emerse anche la figura del sommelier e del suo strumento di valutazione, come “tecnico” indispensabile per i cantinieri. Questo spiega innanzitutto il motivo per cui l’utensile è di metallo – argento o argentato – e non di vetro. I sommelier dovevano spostarsi a cavallo tra una vigna e l’altra, per cui il vetro sarebbe risultato troppo fragile, mentre il metallo è infrangibile e di facile trasporto. In più, anche nelle cantine poco illuminate, l’argento poteva riflettere la luce permettendo così di giudicare subito il colore e la limpidezza del vino, con l’ulteriore vantaggio che il nobile metallo favorisce il dissolvimento dell’anidride solforosa presente nei vini bianchi giovani.
Sin da subito si hanno due versioni del tastevin, originate una in Borgogna e l’altra a Bordeaux. Dal ‘700 in poi prevarrà quella borgognese che verrà adottata più o meno ufficialmente dai degustatori, in quanto più completa, tanto che manterrà inalterata la forma fino a oggi.
Il piattino ha un diametro di 8cm e 2cm di profondità. Esso è assicurato alla catena con un moschettone e presenta un piccolo manico o poggiadito che ha una funzione specifica in quanto è in relazione con le scalfitture e gli incavi presenti nella superficie interna. È evidente che quello che sembra un arbitrario lavoro di filigrana è in realtà uno strumento di misurazione.
Per analizzare i vini bianchi si pone il poggiadito a sinistra e si versa il vino con la mano destra. Per i rossi è l’incontrario. Il fondo del piattino è convesso per limitare la misura del vino da versare, che non deve superare la bolla di livello. Intorno ad essa ci sono altre 14 piccole bolle in rilievo sulle quali si fa roteare il vino per facilitare l’ossigenazione e sprigionare i profumi. Quest’operazione favorisce il bilanciamento dell’acidità e dei tannini presenti nel vino e ne armonizza il sapore. Lo spazio sopra le bolle è quello che dà informazioni specifiche sul vino bianco o rosso. Lungo un semicerchio ci sono 8 avvallamenti di diversa profondità, detti perle, che permettono di fare l’esame visivo della chiarezza e colore dei vini rossi. Mentre la valutazione oculare dei vini bianchi si fa sul lato opposto dove ci sono 17 nervature, incisioni di forma allungata, che sono più adatte per determinare la tonalità e la limpidezza dei vini bianchi.
Si può ben capire quante informazioni vengano offerte al sommelier prima ancora di passare alla degustazione. Allora perché questo strumento così efficiente è diventato obsoleto? Perché per quanto elaborato, ha i suoi limiti, che i moderni bicchieri hanno superato.
La sua forma aperta non acconsente l’approfondito esame del bouquet del vino, in quanto gli aromi si disperdono troppo rapidamente. Già qui possiamo capire che una boccia di cristallo finissimo che si racchiude verso l’alto offra al naso uno spazio impareggiabile per analizzare il profumo del vino. In secondo luogo le dimensioni e la forma del tastevin non sono adatte a valutare il perlage – le bollicine di effervescenza – degli spumanti.
Oggigiorno i sommelier hanno a disposizione tutta una serie di bicchieri di materiale di altissima qualità. Inoltre negli anni ‘70 è stato ufficialmente adottato il bicchiere ISO (International Standards Organization), frutto delle ricerche dell’enologo Jules Chauvet, dalle forme e dal materiale dettagliatamente codificati.
Il calice, a forma di tulipano chiuso, è alto 15,5 cm, di cui 10 cm di bicchiere e 5,5 di stelo; i diametri di orlo, pancia e base sono rispettivamente di 4,6, 6,5 e 5,5 cm, con una capacità compresa tra i 210 e i 225 ml ed è considerato il mezzo ideale per valutare la maggior parte dei vini.
Insomma, durante la degustazione di un vino, tutti sono capaci di tenere in mano un calice, far roteare il liquido, annusare e assaporare. Ma solo quello con il piattino al collo sa farlo professionalmente.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.