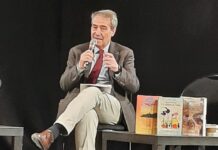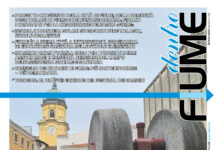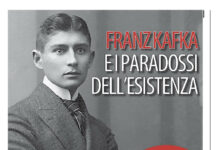Siamo ottimisti o pessimisti? Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Lo chiedo perché in questo periodo alcuni miei amici vanno in crisi in quanto “le giornate cominciano ad accorciarsi”. Da notare che l’estate è appena iniziata e si stende davanti a noi, calda e piena di promesse. Però per loro… niente da fare. Il danno è fatto. D’altronde si può comprendere benissimo questo stato d’animo. Da Pasqua in poi c’è stato un crescendo di luce, un’esplosione di energie vitali, che sono culminate al solstizio, il quale però ha dato anche il via alla fase di restringimento. Forse è proprio il giro di boa che rammarica i cultori dell’espansione ad oltranza, quelli che avranno la seconda crisi in autunno, quando il ritorno all’ora solare decurterà ancora di più la loro gioia delle ore di luce.
Se tutto questo succede a noi, figuriamoci come si sentono quelli che vivono a latitudini maggiori. Si sa che più si sale verso i poli e più lo scarto tra notte e giorno aumenta intorno alle date cruciali di giugno e dicembre. Si è studiato molto l’effetto deleterio che mesi di giornate brevi e tanta notte hanno sulla psiche (in fondo gli scandinavi non sono conosciuti per il loro spirito allegro). Si parla di meno delle giornate molto lunghe, forse dando per scontato che, non avendo controindicazioni, non ci sia troppo da dire. Ed in effetti non c’è altro da aggiungere eccetto che è un’esperienza a dir poco esaltante.
Andando ad abitare a Belfast, avevo già messo in conto che gli inverni sarebbero stati più cupi, ma d’altronde a dicembre e gennaio fa buio presto anche da noi. Comunque quando si lavora, nel tran-tran giornaliero, si bada poco alla fine della giornata. Nel mio orario lavorativo ci sono le lezioni pomeridiane dalle due alle quattro, e quelle serali dalle sette alle nove. In inverno già quando torno a casa dopo le quattro, siamo immersi nella penombra crepuscolare, mentre alla sera si va e si torna con il buio pesto. Ma, come dicevo, era già tutto calcolato. Quello a cui non ero preparata, e che è stata una sorpresa emozionante, è quando da metà aprile in poi si va a lezione alle sette che è chiaro e si esce alle nove che è ancora giorno. È una sensazione bellissima e destabilizzante allo stesso tempo, perché le abitudini del resto dell’anno dicono che è ora di andare a casa, mangiare qualcosa rilassarsi con le occupazioni serali, ma il sole che splende ordina di stare svegli, di uscire di fare qualcosa di dinamico. E non finisce qui. In questo periodo tutte le fasi di luce risultano dilatate. Il sole tramonta dopo le dieci, però il cielo resta luminoso ancora a lungo per cui il crepuscolo si affievolisce solo intorno alle undici e la notte non è mai nera-nera, ma permane un chiarore a ovest, che nel corso delle ore seguenti si sposta progressivamente verso est e sbianca annunciando l’alba, già prima delle quattro di mattina. Cosicché la notte vera dura tre orette scarse, precedute e seguite da un’ora di semichiarore e poi c’è il giorno pieno. Tutto questo è a dir poco energizzante.
Con questa esperienza, sono andati a posto anche vari dettagli di libri stranieri che mi avevano confusa in passato, a cominciare dalle “Notti bianche” di Dostoevskij, in cui due giovani dall’animo sensibile si incontrano per quattro notti di seguito nel periodo di massima durata delle giornate di San Pietroburgo. Anche se nella prefazione viene spiegato il significato di “notte bianca”, averlo provato è tutta un’altra cosa, e questo aggiunge spessore alla lettura. Allo stesso modo si comprende meglio anche “Il libro dell’estate” dell’autrice finlandese di lingua svedese Tove Jansson, come anche altre opere di letteratura scandinava. Ritornando in Irlanda, all’epoca degli studi triestini, non mi tornavano i conti sul computo del tempo nell’“Ulisse” di James Joyce. Percepivo una discrepanza tra i vagabondaggi di Leopold Bloom a Dublino il 16 giugno 1904 e le ore di luce che io credevo fossero disponibili in tale giornata. Dopo un anno a Belfast tutti i dubbi si sono chiariti.
Se adesso qualcuno mi chiede quale sia il momento migliore per visitare l’Irlanda, consiglio sempre maggio-giugno: sul tempo meteorologico non si può contare (l’estate 2023 ad esempio è stata piovosissima) ma la durata delle giornate è sistematica.
Per apprezzare a fondo quanto sopra riporto gli orari ufficiali di tramonto e alba per l’Istria, Belfast e la zona tra San Pietroburgo e la Scandinavia, riguardanti il solstizio appena passato. Da noi il sole è tramontato alle 20.57 e si è levato alle 5.15; a Belfast alle 22.04 e 4.47; lungo la fascia tra San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Oslo il sole è calato tra le 22.08 e le 22.50 e si è levato tra le 3.31 e le 3.54. Bisogna dire che un’intera ora di giorno in più fa un’enorme differenza.
Ma solo una capitale in Europa gode del fenomeno del sole a mezzanotte ed è Reykiavik in Islanda, dove gli orari sono stati 00.03 e 2.25. Praticamente il sole non ha neanche fatto in tempo a tramontare che già è risorto.
Per completare il quadro dei riferimenti letterari, è doveroso menzionare il “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare ambientato tra il 23 e 24 giugno (notte di San Giovanni per noi, Midsummer per il paganesimo precristiano). La domanda sorge spontanea: come si può parlare di mezza estate quando siamo praticamente al solstizio? Ebbene se riprendiamo il discorso sul calendario celtico che abbiamo menzionato nel bozzetto su Halloween, ricorderemo che le due date spartiacque dell’anno erano le festività di Samhain, il primo novembre, e di Beltane il primo maggio. Questo modo di suddividere l’anno si era diffuso a nord, arrivando fino alle popolazioni scandinave (ancora oggi Midsommer è la denominazione della festa per il solstizio in Svezia). Dunque, dal primo maggio al 21/24 giugno trascorre più di un mese e mezzo, ovvero mezza estate. Il mistero è risolto.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.