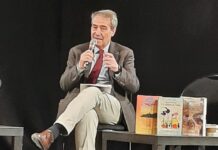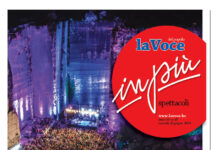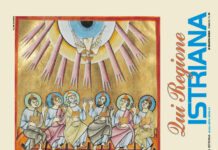In occasione della XXII Settimana della lingua italiana nel mondo, il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume, ha organizzato una lezione intitolata “Esiste ancora un linguaggio giovanile?” tenuta dal prof. Michele Cortelazzo, professore di Linguistica all’Università degli Studi di Padova.
Il benvenuto ai presenti è stato dato dalla capodipartimento Corinna Gerbaz Giuliano, la quale ha ricordato che l’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e con il Comitato di Fiume della Società Dante Alighieri.
Il contributo del relatore
A salutare studenti e autorità è stato pure il preside della Facoltà, Aleksandar Mijatović, il quale ha espresso una curiosità personale riguardo al tema della lezione.
“Per me è un grande piacere aprire una conferenza dedicata al linguaggio giovanile, un soggetto interessante nella linguistica – ha dichiarato Mijatović -. Reputo che studiando questo fenomeno possiamo cambiare regole predefinite. Sono onorato di presentare il prof. Cortelazzo e ricordo che il nostro Dipartimento di Italianistica celebra il suo decimo anniversario. Il prof. Cortelazzo ha contribuito al suo sviluppo sin dai suoi inizi e noi gliene siamo grati. Per quanto riguarda il linguaggio giovanile, noi concepiamo il nostro linguaggio come immutabile, ma sappiamo che associazioni si impongono ai parlanti e la competenza linguistica non sempre segue una legge o regola. Il linguaggio è copioso di luoghi comuni e frasi fatte e la sua struttura è governata da regole, ma nonostante tutto cambia impercettibilmente nel tempo. L’equilibrio tra immutabilità e cambiamento è lo spazio nel quale i parlanti esprimono le proprie idee”.
Lingua autoctona
Un breve intervento è stato fatto pure dal Console Generale d’Italia a Fiume, Davide Bradanini, il quale ha ricordato l’importanza della Settimana della lingua italiana nel mondo, una rassegna celebrata da tutta la rete diplomatico-consolare e dagli Istituti di lingua italiana nel mondo, inclusa la Croazia, di cui fanno parte il Consolato di Fiume, l’Ambasciata di Zagabria e l’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. “‘L’italiano dei giovani’ è un tema importante che tocca da vicino l’Istria e Fiume, la zona d’insediamento storico della nostra CNI, in quanto l’italiano è una lingua d’uso locale e non straniera – ha ricordato Bradanini -. L’italiano non viene esportato dall’Italia come succede con la Francia, la Germania o gli Stati Uniti d’America. Qui l’italiano è una lingua autoctona e quest’aspetto va messo in luce, a mio parere, anche dalle ricerche linguistiche. Sarebbe interessante scoprire se esiste un italiano giovanile dei nostri territori e mi auspico che presto lo verremo a sapere”.
Il linguaggio tra parlato e scritto
All’inizio della sua lezione, il prof. Michele Cortelazzo ha ringraziato gli organizzatori e ha ricordato che negli ultimi dieci anni è stato presente al Dipartimento di Italianistica di Fiume per almeno un semestre all’anno, a parte la pausa dovuta alla pandemia. Visto che il 2022 è stato proclamato “Anno europeo dei giovani”, è giusto esplorare anche l’aspetto linguistico di questa categoria sociale. Il primo fenomeno di cui ha parlato e quello forse più recente, in quanto risale alla primavera di quest’anno è il “parlare in corsivo”, nato su TikTok.
”Il corsivo è stato il tormentone dell’estate – ha illustrato Cortelazzo – e ha imperversato in base a un meccanismo interessante. Dopo il boom dei social l’iniziativa è stata assorbita dalle televisioni, contagiando anche un medium più tradizionale. Questo fenomeno ci insegna che esiste una propensione tra i giovani a deformare in senso ludico esperienze comunicative della società. Si deforma la lingua per gioco o per scherzo. L’interesse della catena fonica è una costante nella lingua italiana. Alcune delle caratteristiche del linguaggio giovanile sono la passione per la parodia, in questo caso dell’inflessione milanese propria di molti influencer, la non riducibilità del linguaggio giovanile al solo lessico e l’effimerità delle innovazioni giovanili.
La componente sociale viaggia in Rete
“La centralità dei social network come luogo per la diffusione delle innovazioni, il ruolo dei media ‘tradizionali’ per la diffusione della conoscenza delle innovazioni linguistiche, l’intreccio sempre più stretto tra oralità e scrittura (parlare in corsivo, tipico della scrittura) sono altre caratteristiche tipiche dei nuovi fenomeni linguistici giovanili. Penso che la linea di demarcazione tra scritto e parlato si sia fatta talmente sottile, che spesso non la vediamo. Una volta scrivere voleva dire rileggere e correggere ed è questo quello che differenzia il processo di stesura di un testo dalla comunicazione. Il scritto dei social, invece, solitamente contiene errori che non vengono cambiati, proprio come avviene con il parlato. Una volta che diciamo una frase, anche se questa frase contiene un errore, non possiamo tornare indietro per cancellarla, al massimo possiamo scusarci”.
Il prof. Cortelazzo ha parlato anche dei fenomeni sociali legati ai giovani, come ad esempio gli incontri di gruppo. Per la maturazione di dinamiche linguistiche giovanili una volta era necessaria l’appartenenza a un gruppo (classe, palestra o altri centri di socializzazione). Oggi la componente sociale e comunicativa si è trasferita sulle piattaforme digitali e di conseguenza si è ridotta la varietà degli usi linguistici giovanili. Le varie regioni italiane parlano in un linguaggio molto più simile e uniformato. Vari studi storici dagli anni Ottanta ad oggi hanno analizzato tutti i cambiamenti che hanno interessato il linguaggio giovanile (come ad esempio quello di Lorenzo Coveri o Gianluca Lauta). Anche in questi giorni, proprio in occasione della Settimana della lingua italiana, il relatore ha ricordato che la Crusca offre un’e-book gratis fino al 24 ottobre, “Come scusa? Non ti followo” a cura di Annalisa Nesi.
Periodizzazione stratificata
Nel corso della lezione il professore ha proposto alcune parole ed espressioni del linguaggio giovanile, tra cui pure parole che sopravvivono alle generazioni, voci gergali, voci dialettali, anglicismi dai social o dalla musica rap e altro, ma si è soffermato sullo sviluppo storico di questo tipo di lessico, che un centinaio di anni fa non esisteva.
La nascita del linguaggio giovanile può venire collocata negli anni Trenta del Novecento, il periodo di composizione del “Garofano rosso” di Elio Vittorini, nella cui elaborazione troviamo le prime tracce consistenti, non tutte confluite nell’edizione in volume, dell’esistenza di una gergalità giovanile. Tale linguaggio è legato a una condizione studentesca e quindi all’appartenenza dei ceti medio-alti ed è localizzato nelle grandi città, soprattutto Milano. Ne troviamo tracce nei romanzi. All’epoca chi studiava era privilegiato, perché sennò si andava a lavorare e dunque il periodo che noi chiamiamo giovinezza era ristretto a pochi anni.
Nel 1968, gli anni della contestazione, il linguaggio giovanile, proprio in quanto linguaggio prima di tutto studentesco, attenua la propria presenza, sovrastato dal cosiddetto sinistrese, varietà ricca di stereotipi non esclusivamente studentesca. Nella seconda metà degli anni Settanta, però, c’è stato un “riflusso” caratterizzato da un ritorno al privato e comunicativamente al “parlare di sé”. Si assiste a una ripresa della diffusione delle forme espressive giovanili consistente nel rifiuto dei tabù linguistici, soprattutto per le donne. Le ragazze iniziano a dire “Mi sono rotta le palle” e si rafforzano nuove forme di linguaggio. Negli anni Ottanta, in quello che definiamo il post moderno, si assiste al dilagare del linguaggio giovanile. È in questo periodo che i giovani tendono a marcare la loro identità attraverso la scelta di stili comunicativi precisi che caratterizzano i gruppi di appartenenza. Anche vestiario e accessori, nonché la scelta dei luoghi d’incontro seguono questa tendenza.
Negli anni Novanta il linguaggio giovanile, da fenomeno metropolitano diventa fenomeno universale e si diffonde velocissimamente anche al sud, ma si allarga la sua presenza anche a fasce d’età sempre più ampie, parallelamente all’ampliarsi della condizione giovanile. Una volta gli studenti erano considerati adulti, adesso sono pienamente nella condizione giovanile tipica della scuola media superiore. Il risultato è stato la polverizzazione dei modelli, delle tendenze e, per quel che ci interessa di più, delle espressioni linguistiche. L’evoluzione tecnologica e la comunicazione digitata hanno portato a un’estensione degli ambiti di utilizzo. Il numero limitato di caratteri degli SMS ha portato a una casuale convergenza di interessi: il linguaggio è stato sempre più contrassegnato da brevità, andamento veloce come i DJ, colloquialità ed espressività.
La situazione odierna
“Dopo il 2018 abbiamo avuto una confluenza nella lingua dei social – ha rivelato Cortelazzo -. Negli ultimi anni si verifica il dissolversi della creatività linguistica dei giovani nella più generale creatività comunicativa indotta dai social e legata ai video condivisi su tali piattaforme. La lingua assume un ruolo ancillare e le innovazioni lessicali risultano funzionali alla rappresentazione dei processi di creazione e condivisione dei prodotti multimediali. I gruppi giovanili si generalizzano e aumenta la stereotipia (e anche la forte anglicizzazione) e il linguaggio giovanile non appare più significativo in sé, come espressione della creatività giovanile, che si sviluppa ora, preferibilmente, in altri ambiti. In conclusione, il linguaggio giovanile era un tema di ricerca interessante per i suoi risvolti sociali, ma anche per il contributo che può dare alla conoscenza delle varietà dell’italiano. Era una delle varietà dell’italiano più ricche, varie e dinamiche. Oggi la centralità del video rispetto allo scritto ha ridotto la ricchezza e le varietà (sociale e geografica) di tale linguaggio. Pensiamo soltanto all’uso di Whatsapp e alle chat che non contengono più messaggi scritti ma video o vocali. Mi chiedo, dunque, se ha ancora senso di parlare di un italiano giovanile (innovativo). Anche se stiamo assistendo alla perdita di questo tipo di linguaggio, reputo sia affascinante il fatto che possiamo analizzare tanti fenomeni che una volta un parlante non vedeva nell’arco della sua vita, perché viviamo di più e i cambiamenti sono più repentini”, ha concluso Cortelazzo.
All’incontro alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume erano presenti anche gli studenti della SMSI di Fiume, le matricole e gli studenti dell’Università di Fiume.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.