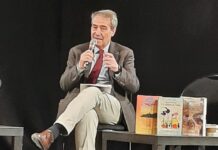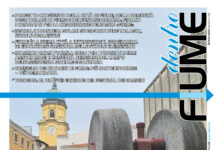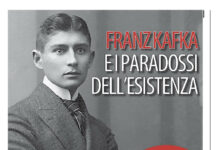FIUME Considerati gli straordinari concerti ai quali abbiamo assistito nell’attuale stagione teatrale dell’”Ivan de Zajc”, ai quali si sono presentati non soltanto interpreti di prestigio, bensì anche opere musicali di massimo valore artistico – a volte meno note e pertanto benvenute in quanto educative e in funzione dell’ampliamento del repertorio dell’Orchestra dell’Opera, oppure famose ma assenti da decenni sui podi concertistici di Fiume –, giovedì scorso abbiamo assistito ad ancora un serata di pregio. Questa volta, nel programma si sono trovati il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 77, di Johannes Brahms, e la Sesta sinfonia in Si minore, op. 74, chiamata “Patetica”, di P.I. Čajkovskij, con in veste di solista il valente violinista connazionale Marco Graziani, sotto la direzione del Mº Pavle Dešpalj.
Il Concerto per violino e orchestra di Brahms venne composto nel 1878 ed ebbe la sua prima esecuzione il 1.mo gennaio 1879 a Lipsia, sotto la direzione dello stesso Brahms, con in veste di solista l’amico del compositore, Joseph Joachim. L’opera non fu accolta con troppo entusiasmo dal pubblico, mentre i critici espressero opinioni diverse sul suo conto. Infatti, all’epoca il pubblico si aspettava una composizione nella quale il violino possa mettere in mostra le sue capacità virtuosistiche, mentre all’orchestra era riservato il ruolo di accompagnamento. Questo concerto, invece, venne concepito come un’opera organica, nella quale il violino e l’orchestra sono sullo stesso piano e concorrono equamente nella costruzione del quadro musicale. È per questo motivo, per esempio, che alcuni violinisti famosi dell’epoca accolsero freddamente il concerto, in certi casi definendolo addirittura “insuonabile” (Henryck Wieniawski), mentre il violinista e compositore spagnolo Pablo de Sarasate si rifiutò di suonarlo commentando: “Pensate che me ne possa stare lì con il mio violino in mano a sentire l’oboe che suona l’unica melodia nell’intero pezzo?“.
Oggidì, però, questa è considerata una delle composizioni più riuscite di Brahms e uno dei concerti per violino più famosi nella storia della musica. L’ispirazione per la stesura di quest’opera è stato il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, di Beethoven.
Segmenti virtuosistici
Il Concerto, che si articola in tre movimenti, si apre con un’introduzione che combina un’atmosfera intimistica con passaggi di respiro sinfonico e meravigliose linee melodiche affidate all’orchestra. I difficili segmenti virtuosistici che costellano quest’opera sono stati eseguiti con pertinenza da Marco Graziani, anche se nell’insieme avevamo l’impressione che il violinista si sentisse leggermente indisposto durante l’esibizione. Trattandosi di una composizione tipicamente romantica, ricca di passione e dinamica, nell’interpretazione di Graziani non sarebbe dispiaciuto un po’ più coinvolgimento emotivo e più verve, soprattutto nelle cadenze. Il pubblico ha apprezzato la sua interpretazione, per cui Graziani ha offerto un breve bis.
La seconda parte del concerto era riservata alla Sesta sinfonia di Čajkovskij, un’opera composta nel 1893 ed eseguita per la prima volta il 28 ottobre 1893 a San Pietroburgo, sotto la direzione del compositore stesso. L’ultima sinfonia del compositore russo viene da molti considerata il suo requiem sinfonico, forse per sé stesso. Čajkovskij morì nove giorni dopo la prima esecuzione. “Non ho mai composto niente di più bello di questa sinfonia e mai più lo farò: vi ho investito, senza esagerare, tutta la mia anima”, disse a suo tempo Čajkovskij a suo nipote Vladimir Davidov. Tra i suoi scritti è stata trovata la descrizione di questa sinfonia, nella quale egli spiega che nel primo movimento c’è la passione impulsiva, nel secondo l’amore, nel terzo le delusioni, mentre nel quarto la morte, il riflesso della sconfitta finale.
Una descrizione che calza a pennello l’esecuzione diretta dal Mº Dešpalj, nella quale la straordinaria Orchestra dell’Opera ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza. Di volta in volta, questo organico sembra scalare vette sempre più alte di qualità, merito anche dei direttori d’orchestra con i quali ha la fortuna di collaborare. Uno di questi è senza dubbio il Mº Dešpalj, il quale ha tenuto sotto controllo con un gesto minimalista tutte le sezioni dell’orchestra, guidandolo in un viaggio emozionante nei vari stati d’animo presentati nella splendida Sesta sinfonia.
Particolarmente emozionante è stata l’esecuzione del terzo movimento, che si basa su un ironico motivo di marcia e che – nonostante il galateo dei concerti di musica classica prescriva che non si applaude durante l’esecuzione di una composizione ciclica, in questo caso di ciascun movimento, bensì soltanto alla sua fine – ha indotto diverse persone nel pubblico a fare uno strappo alla regola per esprimere il proprio apprezzamento dell’esecuzione.
Meritati e calorosi gli applausi alla fine del concerto.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.