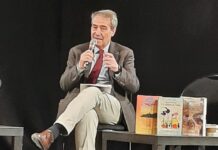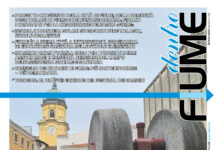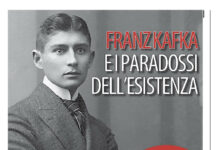Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas, Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi, al secolo Antonio de Curtis di Bisanzio, nato nel 1898 a Napoli, nel Rione Sanità in via Santa Maria Ante Secula. Senza padre, prende il cognome della madre Anna Clemente, donna di modeste condizioni. Conclusa la scuola elementare viene mandato in collegio. In seguito a un incidente subito giocando a boxe si ritrova col setto nasale deviato e la mascella rientrante. Anni dopo questi difetti saranno un elemento essenziale per la costruzione della maschera naturale di Totò.
Esordisce a teatro giovanissimo, prima con la commedia dell’arte e poi interpretando macchiette nello stile dei fantasisti del Cafè Chantant. A Roma, nel 1917, al teatro Jovinelli conquista il pubblico con il numero della marionetta disarticolata; una tecnica ereditata dal contorsionista Gustavo De Marco. Dopo il servizio militare si esibisce con crescente successo nei caffè concerto di Napoli, Milano, Torino per approdare nel 1925 a Roma alla sala Umberto dove la sua maschera comica sarà un trionfo. Presenta un personaggio furbo, trasgressivo, vorace a metà strada tra Pulcinella e Arlecchino. Nel frattempo la madre di Totò sposa il nobile decaduto Giuseppe De Curtis, il quale dichiara di avere avuto a suo tempo una relazione con Anna Clemente e di essere il padre di Antonio. Questo permetterà a Totò di fregiarsi, anche se tardivamente, del proprio cognome e di poter vantare una nobile discendenza. Nel 1930 la sua amante, la bellissima Liliana Castagnola, si suicida perché si sente trascurata. Totò rimane sconvolto dalla tragedia. Dal secondo matrimonio con Diana Bandini Lucchesini Rogliani avrà una figlia che chiamerà Liliana De Curtis. Pagherà però la sua fama di “tombeur de femmes” vedendosi recapitare una richiesta di divorzio e poi anche l’annuncio dell’addio definitivo da parte della Rogliani. L’esperienza lo porterà a scrivere la celebre canzone Malafemmina. Morto a Roma nel 1967 a 69 anni, è oggi riconosciuto dalla critica come il più grande comico italiano del ‘900. Ma fu anche commediografo, poeta, paroliere e sceneggiatore. Da ascoltare, recitata dalle sue labbra, la sua più famosa poesia A livella (che proponiamo a lato nella versione in italiano), testamento massonico, in cui si ritiene abbia espresso i suoi sentimenti e valori di appartenenza alla massoneria italiana.

Le origini: nobiltà ed estrema povertà
Alla fine degli anni ‘20 Totò compie una scelta che per lui ha una grande importanza, in cambio di un vitalizio riesce a farsi adottare da un nobile. Ha sempre avuto l’ossessione del sangue blu, si dice che il padre fosse un nobile… Ad esempio, Edoardo Clemente, suo cugino e segretario, raccontò che la nonna paterna gli disse che era figlio di un ingegnere inglese che partecipò alla costruzione degli stabilimenti di Bagnoli dell’Ital-Sider. In un celebre filmato delle Teche Rai, intervistato dal giornalista Lello Bersani, Pasolini racconta di una mancia da 20mila lire che Totò avrebbe dato a un cameriere. Pasolini in modo provocatorio lo descrive per questo gesto come uno “strano principe”, perché non si era manifestato taccagno “come lo sono tutti i principi”.
Quello che è certo è che la sua infanzia fu contraddistinta da un’estrema povertà e che un colpo di boxe fece “deragliare” il naso e il mento consentendogli, sembra, di scoprire le sue capacità mimiche e la possibilità di far ridere gli altri, doti che poi gli consentirono di “campare” grazie alle prime recite nei vicoli di Napoli, alle imitazioni proposte nei teatrini della ferrovia e successivamente ai lavori nella rivista e nell’avanspettacolo prima della proiezione del film. Impressionava il pubblico teatrale con le capacità da contorsionista e per questo veniva messo a confronto con le avanguardie, in particolare con il futurismo per le scomposizioni del suo corpo e del volto. La sua proposta artistica s’ispira prima ancora che alla maschera di Pulcinella ai modelli di una comicità antica delle Atellane di Plauto, farse contadine da cui poi, secondo molti esperti, nasce tutta la comicità italiana.
Scarpetta e l’“assalto” agli spaghetti
Il suo gioco comico cardine nasce spesso da situazioni dettate dalla fame; non solo di cibo – con l’“assalto” di Scarpetta agli spaghetti in Miseria e Nobiltà, ma anche di sesso. Sono gli anni della Democrazia Cristiana, di Pio XII, dei bordelli e di una fortissima repressione sessuale e Totò esprime questa “fame” in molti modi, criticando anche la classe dirigente e cattolica del tempo. Ad esempio, nel film Fifa e arena, parodia del romanzo e poi film Sangue e Arena, è proverbiale la scena in cui Totò vede, attraverso un acquario, Isa Barzizza in una stanza vicina che si spoglia, ma nel momento culmine dello spogliarello un pesce attraversa il vetro davanti a Totò e lui esclama: “Pesce democristiano!”, una battuta che sconvolse l’Italia del tempo.

Voglia di spazio
Un altro aspetto che si evidenzia in Totò e che gli sceneggiatori sottolineano e sviluppano nella sua filmografia è quello dello spazio, ovvero del bisogno di spazio. Una voglia che nasce dalla sua vita nei vicoli di Napoli in cui si sta ammassati. Questo bisogno è espresso anche in una farsa napoletana anonima che descrive questo aspetto, successivamente sceneggiato nel film Totò cerca casa. La ricerca di spazio è anche una ricerca di riconoscimento da parte degli altri. Ancora una volta si tratta di “fame”, questa volta di onorabilità. Come non ricordare a proposito la frase di Totò: “Lei non sa chi sono io”, tipica di una borghesia frustrata oppressa dalla paura di essere invisibile. Un tema pirandelliano, ben rappresentato nell’episodio La patente (Questa è la vita) e nel film L’uomo, la bestia e la virtù, sempre interpretati da Totò. La fame e l’irrequietezza metafisica portano spesso Totò a uscire dai limiti del corpo umano, come con la marionetta di Pinocchio o arrampicandosi sui teloni dei palcoscenici. Unisce così da una parte l’aspetto realista attraverso la maschera di Pulcinella e dall’altra quello iperrealista con l’uomo-marionetta.
La figura del mamo
Nella tradizione comica il mamo è il nuovo nato, lo stordito, lo sciocco, quello che arriva in un contesto di cui non sa nulla. Il film Totò Tarzan ha come protagonista un essere che non sa nulla; Pinocchio e Il figlio di Iorio, come Tarzan, sono personaggi che entrano e sconvolgono l’ordine perché non sanno vivere in società, non possono essere accettati. Una novità antica e moderna è quella del mamo magistralmente riletta in chiave contemporanea da Totò. Saranno gli intellettuali italiani – Aldo Palazzeschi, Massimo Bontempelli, Alessandro De Feo, Cesare Zavattini, Umberto Barbaro – che si accorgeranno presto della sua genialità e dopo averlo ammirato lo elogeranno prima a teatro e poi al cinema. Tuttavia, questi stessi intellettuali faranno fatica a riconoscerlo come un attore completo, indipendente.
I film parodia
Nell’Italia del dopoguerra la fama di Totò supera quella di attori comici come Aldo Fabrizi, Eduardo e Peppino De Filippo; i primi due rivali in arte, mentre Peppino sarà una spalla mirabile. In alcuni film si può ammirare la capacità di improvvisare di due grandi attori di tradizione napoletana popolare, cresciuti sugli stessi palcoscenici di Napoli. Memorabili nella scena sulla discussione della tomba di famiglia: “Un puttino una colonna, una colonna un puttino…” del Barone Zazà in Signori si nasce. Finito il neorealismo, Totò viene recuperato a una storia sociale fatta dalle parodie di film famosi con titoli che diventano altro rispetto al film originario. Queste parodie sono anche un modo per cercare un legame con l’attualità di quegli anni, con la quale sia Totò sia gli sceneggiatori e i registi creano un gioco di rimandi continuo. Con l’arrivo dei grandi registi, come Mario Monicelli con Totò cerca casa e poi con Guardie e ladri, esplode l’idea di un Totò recuperabile a un discorso realistico. Poi arrivano anche molti altri a occuparsi di Totò e Pier Paolo Pasolini lo rilancia con Uccellacci e Uccellini e con due episodi bellissimi La terra vista dalla Luna e Che cosa sono le nuvole, in cui Totò raggiunge momenti altissimi, ma va citato anche Alberto Lattuada con il personaggio del prete ruffiano ne La mandragola (basato sul libro di Machiavelli). Anche Fellini aveva progetti sulla figura di Totò mai realizzati però a causa di questioni legate ai costi esorbitanti dell’attore.

L’improvvisazione
I registi e gli sceneggiatori con il quale Totò collaborava – Mario Mattoli, Steno, Age & Scarpelli, Ruggero Maccari… – avevano una forte sensibilità per quel mondo sul quale con gag e improvvisazioni Totò rielaborava qualcosa di assolutamente personale. Scene che stando al copione dovevano durare una manciata di minuti, ma che complice anche Peppino De Filippo, potevano durare molto più a lungo in virtù dell’arte di improvvisare che migrava così dal teatro al cinema. L’improvvisazione andava a calarsi in una sede non naturale e per poter ugualmente consentire questa tecnica espressiva si ricorreva a regie chiamate “a teatrino” con la macchina fissa come fosse a teatro, nella forma usata anche da Charlie Chaplin per Charlot. Totò però soffriva per il fatto di essere ignorato all’estero. In Francia si presentò con Fernandel nel film La legge è legge, una sorta di nuovo don Camillo andata a vuoto per il poco seguito. Scongiurava pertanto Carlo Ponti e Dino De Laurentis di produrre un film muto per tentare di presentarsi all’estero come mimo e avere la possibilità di rendere le sue qualità comprensibili a tutti. La parola, sosteneva Totò, gli veniva “stretta”. A proposito si rifiutava sempre di raccontare le barzellette alla Erminio Macario o alla Carlo Dapporto. Si considerava un comico visivo.
Ignorato e poi riscoperto
Tra il ‘67 e il ‘72 Totò viene dimenticato, Poi un distributore ripropone l’astrazione mimica più bella dell’attore, il primo film italiano a colori: Totò a colori, che propone una serie di sketch famosi come quello del vagone letto che grazie all’improvvisazione raggiunse la mezz’ora. Nel post ‘68 Totò genera entusiasmo anche nei giovani, che si riconoscono lontani dal perbenismo della cultura del tempo, una moda definita da Pasolini “piccolo borghese”. Da allora Totò resterà presente in tutti i canali tv italiani, entrerà nella televisione come una presenza che ci fa compagnia, che ci ricorda il passato e che anche se ascoltato distrattamente, cresciuti con quelle gag, si imprime nella memoria di molte generazioni. Oggi torna a essere dimenticato, forse perché in generale non c’è bisogno di ricordare. Ci si affida alla Rete o si viene distratti dai nuovi comici che da Zelig sono approdati alla televisione e al cinema offuscando così la memoria dei padri della comicità italiana. Resta comunque un grande artista e con la sua arte aiuta a comprendere una parte dell’Italia e della storia sociale.
La morte rende tutti uguali
Oltre al simbolo della livella presente nell’arte muratoria, con tutti i suoi significati, arriva chiaro il significato della morte inesorabile a renderci tutti uguali. Totò mise in pratica nella sua vita, non piena di sacrifici, i valori e le virtù che questa poesia esprime, la carità con l’attenzione ai bisognosi senza mai dimenticare la sua provenienza e anche in questa forma lasciandoci con un sorriso. Raccontò che la sua fonte d’ispirazione per questa poesia sia avvenuta nell’infanzia mentre giocava a nascondino nelle catacombe di San Gaudioso a Napoli. In una delle numerose corse tra i cunicoli, si imbattè in un’affresco di Giovanni Balducci raffigurante uno scheletro, che simboleggia proprio la natura effimera dei beni mondani, che perdono di senso di fronte al potere della morte, che tutto livella. Da qui la poesia proposta di seguito in una versione in lingua italiana.
La livella
Ogn’ anno, il due novembre, c’è l’usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno deve fare quest’atto di devozione;
tutti devono avere questo pensiero.
Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch’io ci vado, e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo di zia Vincenza.
Quest’anno m’è capitata un’avventura…
dopo di aver compiuto il triste omaggio
(Madonna!) e se ci penso, che paura!
Ma poi mi decisi ad affrontare la cosa.
Il fatto è questo, statemi a sentire:
s’avvicinava l’ora della chiusura:
io, piano piano, stavo per uscire,
gettando lo sguardo su qualche sepoltura.
“Qui dorme in pace il nobile marchese
signore di Rovigo e di Belluno,
ardimentoso eroe di mille imprese,
morto l’11 maggio del ‘31”.
Lo stemma con la corona sopra a tutto…
…sótto una croce fatta di lampadine;
tre mazzi di rose con una lista ‘e lutto:
candele, candelotti e sei lumini.
Proprio attaccata alla tomba di questo signore
c’era un’altra tomba piccoletta,
abbandonata, senza neanche un fiore;
per segno, solamente una crocetta.
E sulla croce a mala pena si leggeva:
“Esposito Gennaro – netturbino”:
guardandola, che pena mi faceva
questo morto senza neanche un lumino!
Questa è la vita! Fra di me pensavo…
chi ha avuto tanto e chi nun ha niente!
Questo povero disgraziato s’aspettava
che pure all’altro mondo era un pezzente?
Mentre fantasticavo su questo pensiero,
s’era già fatta quasi mezzanotte,
e io rimasi chiuso, prigioniero,
morto di paura… avanti ai candelotti.
Tutto a un tratto, che vedo da lontano?
Due ombre avvicinarsi dalla parte mia…
Pensai: questo fatto mi pare strano…
Sto sveglio… dormo, o è fantasia?
Altro che fantasia; era il Marchese:
con la tuba, la caramella e con il pastrano;
quell’altro dietro a lui un brutto arnese;
tutto sporco e con una scopa in mano.
E quello certamente è don Gennaro…
Il morto poverello… lo spazzino.
In questo fatto io non ci vedo chiaro:
sono morti e si ritirano a quest’ora?
Potevano starmi quasi a un palmo,
quando il Marchese si fermò di botto,
si girò e serio serio… calmo calmo,
disse a don Gennaro: “Giovanotto!
Da Voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato!
La casta è casta e va, sì, rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava, sì, inumata;
ma seppellita nella spazzatura!
Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari, tra la vostra gente”.
“Signor Marchese, non è colpa mia,
io non vi avrei fatto questo torto;
è stata mia moglie a fare questa fesseria,
io che potevo fare se ero morto?
Se fossi vivo vi farei contento,
prenderei la cassettina con le quattro ossa
e proprio adesso, in questo momento,
me n’entrerei in un’altra fossa”.
“E cosa aspetti, oh turpe malcreato,
che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!”
”Fammi vedere… pigliala questa violenza…
In verità, Marchese, mi sono seccato
di sentirti; e, se perdo la pazienza,
mi dimentico che son morto e volano le botte!…
Ma chi ti credi d’essere… un dio?
Vuoi capire che qua dentro siamo uguali?…
…Morto sei tu e morto sono anch’io;
ciascuno di noi è proprio tale e quale”.
“Lurido porco!… Come ti permetti
paragonarti a me ch’ebbi natali
illustri, nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?”.
“Ma quale Natale… Pasqua ed Epifania!!!
Ti vuoi mettere in testa… in quel cervello…
che sei malato ancora di fantasia?…
La morte sai cos’è?… è una livella.
Un re, un magistrato, un grand’uomo,
varcando questo cancello, ha messo il punto,
perché ha perso tutto, la vita e anche il nome:
ti sei o non ti sei reso conto di questo?
Perciò, stammi a sentire… non fare il riluttante,
sopportami vicino – che t’importa?
Queste pagliacciate le fanno solo i vivi:
noi siamo seri… apparteniamo alla morte!”.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.