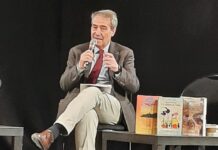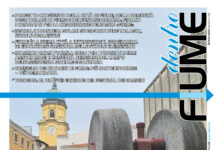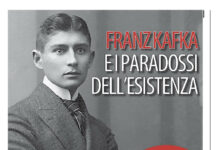Occhi colore zaffiro, guance con tracce di doratura e quello che Lafcadio Hearn (1850 – 1904), scrittore e giornalista di origini greco-irlandesi, definì “l’incantevole sorriso dell’Est”. Sono alcune delle caratteristiche del Grande Buddha (o Daibutsu) di Kamakura, uno dei simboli della città e una delle principali attrazioni turistiche anche a livello nazionale, non soltanto di quella che è conosciuta come una delle antiche capitali del Giappone, che ebbe questo ruolo nel periodo dalla fine del XII secolo fino al 1333, anni che videro l’affermarsi dei samurai come potenza della politica centrale e l’inizio del feudalesimo in Giappone.
Kotoku-in, dove troverete questo Amida-butsu, è soltanto uno dei numerosi luoghi sacri di Kamakura. In questo caso si tratta di uno dei templi buddhisti, ai quali si aggiungono molti santuari shintoisti. La città è situata nella prefettura di Kanagawa, da Tokyo è raggiungibile in treno in circa un’ora ed è una meta di pellegrinaggio grazie ai luoghi che compaiono nei vari anime e in altre opere cinematografiche. Tra queste ultime ci sono pure le pellicole di due grandi registi giapponesi, Akira Kurosawa (1910 – 1998) e Yasujiro Ozu (1903 – 1963), le cui tombe si trovano proprio in questa città.
Nel caso del primo, il film “I sette samurai” viene spesso citato come il suo capolavoro assoluto. Fu proiettato per la prima volta a Tokyo il 26 aprile del 1954. Ciò significa che nella stessa data di quest’anno sono ricorsi esattamente 70 anni: ci teniamo a sottolinearlo in quanto la nostra visita al cimitero in cui si trova l’ultima dimora di Kurosawa si è svolta un giorno prima della stessa ricorrenza. È stato soltanto l’inizio di un’altra giornata del nostro soggiorno a Kamakura, nel corso della quale abbiamo percorso a piedi chilometri e chilometri, scoprendo pure dei vicoli che sembrano usciti da un sogno, santuari e templi che ci hanno accolto, ormai alla fine della stagione 2024 della fioritura dei ciliegi in questa parte del Giappone, con splendidi esemplari appartenenti alla specie tardiva di yaezakura e molti altri fiori.
La bellezza dell’allusività
Abbiamo concluso la stessa giornata in una delle spiagge di Kamakura dalla quale ci siamo goduti uno dei più bei tramonti della nostra vita, reso particolarmente speciale dal Monte Fuji, che durante le tre settimane precedenti giocava a nascondino con noi. Lo faceva anche a Fujiyoshida, dove avevamo deciso di trascorrere due notti per aumentare la possibilità di vedere il vulcano da vicino in tutto il suo splendore, non soltanto la cima o parti di quest’ultima, come durante le due visite degli anni precedenti. Tuttavia, le condizioni meteorologiche non erano (nemmeno questa volta) favorevoli ai nostri desideri.
“Nell’arte giapponese c’è quest’elemento che consiste nel non apparire, rimanere celato, come la luna oscurata dalle nuvole, la persona amata dietro una parete divisoria e persino il Monte Fuji nascosto dalle nubi. Sto dicendo che, in un certo senso, la tua potrebbe essere percepita come una visione unica del Fuji, che appartiene soltanto a te. E questa, già di per sé, può essere vista come una cosa eccezionale”. È la spiegazione, o consolazione, offertaci, in inglese, tramite una rete sociale da un utente del Giappone che ha seguito i nostri post con fotografie scattate a Fujiyoshida. E ha funzionato. La decisione di spiegare la nostra esperienza alludendo al concetto estetico di “yūgen”, che sottintende la bellezza di allusività, suggestione, qualcosa di misterioso, ci ha indotto a pensare di avere un rapporto speciale con il monte sacro. Probabilmente per lo stesso motivo, durante il memorabile tramonto, abbiamo “visto”, in una delle nuvole che facevano compagnia al Fujisan, un drago, ovvero il simbolo dell’anno cinese attualmente in corso. Mentre le onde erano lì… beh, si capisce perché; per offrirci una versione tutta nostra dell’opera ukiyo-e “La grande onda (al largo) di Kanagawa” di Katsushika Hokusai.

Foto: TANJA ŠKOPAC
Il secondo incontro
La spiegazione poetica del nostro “rapporto” con il Fujisan continuava a risuonare nella nostra testa durante il viaggio verso Kamakura. Abbiamo raggiunto l’omonima stazione ferroviaria della città in treno partendo da Tokyo, fino alla quale da Fujiyoshida dovevamo prendere i primi due treni. Dalla stazione centrale di Kamakura, per raggiungere l’alloggio prenotato, abbiamo preso un quarto treno, il cosiddetto Enoden, abbreviazione di “Enoshima Electric Railway”, con cui si può arrivare, tra l’altro, anche alla stazione più adatta per l’esplorazione dell’isola di Enoshima.
Il nostro primo tragitto percorso a bordo di questo treno retro, per il quale anche i protagonisti di un anime ambientato a Kamakura dibattono se sia un treno o un tram, si è, comunque, concluso alla stazione Hase, poco distante dal guesthouse scelto per il soggiorno in questa città. Nelle vicinanze ci sono pure il tempio Hasedera e il Grande Buddha che avevamo visitato per la prima volta nel novembre 2022, raggiungendolo tramite il sentiero intitolato proprio al Daibutsu, che, attraverso alcuni dei boschi e dei colli di Kamakura, collega il Kotoku-in e il tempio Jochiji. Lo avevamo imboccato al posto di continuare a camminare per la strada asfaltata dalla stazione Kita-Kamakura (Kamakura nord), molto meno esigente, probabilmente grazie allo spirito di avventura e alla curiosità un po’ esagerata che ci accompagnano dappertutto.
Dal punto di vista del tempo impiegato, non era una buona decisione. Però l’obiettivo principale, vedere dal vivo il Grande Buddha, era stato comunque raggiunto anche in quell’occasione. Una seconda visita non poteva mancare nel nostro itinerario lo scorso aprile. Anche perché la prima volta, a causa delle restrizioni dovute al coronavirus, non era possibile visitare gli interni della statua, dove, come dice anche una brochure acquistabile presso il tempio, è possibile ammirare le sofisticate tecnologie utilizzate per la fusione della scultura, che è realizzata in bronzo. Oltre a questo e a quanto citato all’inizio di questo testo, vi si legge pure che l’opera, la cui realizzazione iniziò, secondo i dati nell’opera storica “Azuma kagami”, nel 1252, è alta 11,3 metri (più di 13 con il piedistallo) e pesa 121 tonnellate, ma anche l’informazione secondo la quale questo “prezioso esempio dell’arte buddhista in Giappone ha mantenuto nei secoli la sua forma originale”.

Foto: TANJA ŠKOPAC
Fiori e nostalgia
Reso ancora più speciale dai vari fiori in primavera e dai colori del fogliame in autunno, il Grande Buddha è probabilmente uno dei monumenti più fotografati in Giappone. Ciò non è il caso della statua a undici teste di Kannon, dea della misericordia, custodita presso il tempio Hase, ovvero Hasedera, a poca distanza dalla “casa” del Daibutsu e dalla stazione Hase. Alta 9,18 metri, l’opera, che, secondo una leggenda, sarebbe giunta a Kamakura per mare, dopo essere stata scolpita dall’albero sacro usato pure per la scultura raffigurante la stessa divinità custodita nel tempio Hase di Nara, si trova in una sala al cui ingresso sta scritto “vietato fotografare”.
Il complesso è conosciuto anche per le numerose varietà di fiori che vi si possono ammirare nell’arco di tutto l’anno. Nei mesi primaverili a darvi il benvenuto già all’entrata nel tempio saranno delle coloratissime azalee, che nella stessa parte del mondo simboleggiano, dicono alcune fonti, anche la nostalgia di casa, oltre che femminilità ed eleganza. Nel caso del tempio Anyo-in, al quale appartiene il cimitero con la tomba di Kurosawa, gli stessi fiori vengono citati come l’elemento principale al quale si deve la notorietà di questo complesso, a cui si lega il nome di Hojo Masako, moglie del fondatore dello shogunato Kamakura, Minamoto no Yoritomo. Fu spostato, infatti, proprio nello stesso luogo il tempio che lei fece costruire per piangere suo marito.
“Il nome ‘yaezakura’ significa che si tratta di una specie di fiori di ciliegio con tanti petali”. Una giovane donna ha interrotto il proprio lavoro per spiegarci che cosa stavamo fotografando assieme al primo torii (torre d’accesso) del santuario shintoista “trovato” per caso. Si tratta di Yakumo-jinja e, nel momento del nostro arrivo, la giovane era impegnata nella pulizia dell’area del santuario: spazzava via i petali e i fiori caduti della stessa specie di ciliegio a fioritura tardiva, un “tappeto” rosa molto fotogenico che ci dispiaceva vedere rimosso. Ci era già noto il nome della categoria cui appartengono i fiori dal momento che avevamo visto la stessa pianta anche nei giorni precedenti in altri luoghi, Tokyo compresa, ma pure a Kamakura, non lontano dal santuario Tsurugaoka Hachimangu, camminando verso il santuario Zeniarai Benten, dove si va (anche) per lavare il denaro, letteralmente, in modo del tutto legale, per averne di più.

Foto: TANJA ŠKOPAC
«Natsukashii!»
A poche ore dalla breve visita al santuario Yakumo abbiamo immortalato fiori e petali dello stesso tipo attorno alla torre campanaria in stile cinese (e sui suoi tetti) del tempio Jochiji, assieme ad azalee e alla pianta conosciuta come “iris frangiato”. Questo è uno dei cosiddetti Cinque grandi templi zen di Kamakura. Riguardo all’area di Jochiji, sul sito web ufficiale del complesso si legge che vi soggiornò anche il regista Yasujiro Ozu, la cui influenza sui registi contemporanei è stata confermata da Wim Wenders e Tran Ahn Hung, autori di due film piuttosto recenti, rispettivamente, “Perfect days” e “Il gusto delle cose”. Ozu, assieme a sua madre, riposa nel cimitero di un altro tempio zen di Kamakura – si tratta del complesso di Engakuji, situato a due passi dalla stazione di Kita-Kamakura.
Ed eccola, la nostalgia. O forse sarebbe più appropriato sospirare “natsukashii”, un aggettivo che secondo la nota scrittrice italiana Laura Imai Messina, la quale da circa due decenni vive e lavora in Giappone, tra Kamakura e Tokyo, è “una sorta di languore” e “pare l’eredità emotiva di un’era precedente”. “È accettare la natura effimera del mondo, anzi goderne”. In un articolo della BBC lo si spiega innanzitutto come gioia e gratitudine per quanto vissuto, per le esperienze del nostro passato. Un promemoria di quanto siamo fortunati ad averle avute.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.