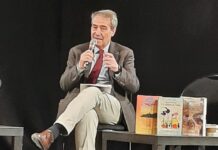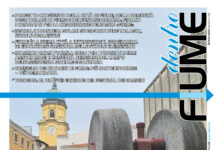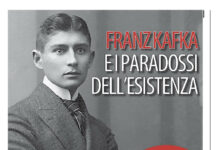A volte, per scoprire e ammirare la bellezza, basta alzare gli occhi al cielo e aguzzare le orecchie. Per accorgersi della magia che ci circonda ci vuole, infatti, soltanto qualche oretta di tempo (che passa sempre troppo in fretta!), un pochino di buona volontà, un pizzico di meraviglia e … Theo de Canziani. Stavolta, lo storico dell’arte è stato affiancato dalla direttrice e dalla curatrice del Museo di scienze naturali, rispettivamente Željka Modrić Surina, e Nadija Dunato Pejnović, nonché dalla biologa Milvana Arko Pijevac, supportati dall’esperienza e sapere di Daina Glavočić per narrare da vari aspetti (storico-culturale, biologico, geologico, botanico) una miriade di meravigliosi aneddoti e dettagli intrecciati e impastati nelle, sotto, sopra e tra le mura, scalinate, terrazze e finestre cittadine.

Foto: GORAN ŽIKOVIĆ
Il Museo di scienze naturali
Il tour, che racconteremo in tre appuntamenti, è stato organizzato dalla succitata istituzione ed è partito dal delizioso orto botanico della stessa, una volta parte integrante dell’immenso e lussureggiante parco Nikola Host che circondava e impreziosiva Villa Giuseppe, costruita alla fine del XVII secolo, appartenente all’intraprendente patrizio aristocratico fiumano Michele Androcha e in seguito all’arciduca austriaco Carlo Giuseppe d’Asburgo, che lo fece ampliare e risistemare. Ad occuparsene furono gli architetti fiumani Pietro e Raffaele Culotti (padre e figlio) i quali, rispondendo alle volontà del ‘sior principe’ (così chiamato dai locali in quanto spesso si aggirava per il mercato senza l’accompagnamento del suo seguito), lo arricchirono con piante, sculture, stagni artificiali, una cascata, e altri dettagli esotici portati dai marittimi da vari Paesi d’oltremare. A seguire, de Canziani ha spiegato che tra i due conflitti mondiali, il conte italiano Alessandro Morosini Prati Negroni fece innalzare la sua villa, successivamente divenuta Museo di scienze naturali, il cui pianterreno è scolpito quasi interamente in pietra naturale che per una serie di particolari (vedi il bovindo su cui poggia il terrazzino) ricorda alcune residenze rivierasche. A suo dire si tratta di un’ architettura moderna, pensata quale residenza familiare in cui, dato che venne spesso usata quale bordello privato del nobile e frequentata dai suoi parenti “uno più pazzo dell’altro”, vi ebbero luogo grandi drammi. Nel 1945, su iniziativa dell’alto funzionario fiumano nonché grande amante della natura, Mario Rossi, fu fondato il Museo e da allora svolge la medesima funzione.

Foto: IVOR HRELJANOVIĆ
Rocce che respirano
A seguire, l’abile cicerone si è soffermato sulla dimensione naturalistica relativa al palazzo, spiegando che “ciò a cui vi voglio fare porre particolare attenzione sono le pietre calcaree nel circondario, che sembrano vivere e pulsare, che caratterizzano anche gli orli che delimitano parti del giardino. Tutto ciò va a creare un ambiente importante in quanto ci riconduce al rinomato naturalista austriaco nonché docente di biologia e ricercatore del carso litoraneo Joseph Roman Lorenz, il quale nel 1876 elaborò il primo progetto concettuale relativo al Museo di scienze naturali rifacendosi al viennese Naturhistoriches Museum, la cui targa onoraria è affissa sulla parete laterale sinistra nelle adiacenze dell’ingresso nell’ente museale”. Ma, da quanto riportato dall’esperto, la storia architettonica relativa alla flora e alla fauna si snoda in svariati palazzi cittadini, movimentandone le facciate e creando una meravigliosa armonia visiva.

Foto: ŽELJKO JERNEIĆ
Il Palazzo del Governo tra ghirlande e leoni
Per darne concreta dimostrazione, seguito dall’incuriosita comitiva, ha scelto quale seconda tappa il monumentale Palazzo del Governo, sede del Museo di Marineria e di Storia del Litorale croato, edificato in stile neorinascimentale tra il 1893 e il 1896 su progetto dell’architetto ungherese Alajos Hauzmann e su iniziativa dell’allora governatore magiaro a Fiume (la città all’epoca faceva parte del Regno d’Ungheria), Lajos Batthyàni. Lo stesso vanta una serie di elementi stilizzati di piante, tradotti in ghirlande di frutta e fiori, nonché alcune teste stilizzate di leoni collocate sopra le finestre principali del piano nobile. Una volta, ha sottolineato, all’epoca in cui vi risiedeva Gabriele D’Annunzio si avvaleva all’entrata di due sculture di leoni seduti sui quali poggiavano dei tronchi e sacchi di sabbia, realizzati dallo scultore fiumano Marietti, oggidì siti nelle adiacenze del padiglione sinistro.

Foto: ŽELJKO JERNEIĆ
L’estro di Emilio Ambrosini
Volgendo lo sguardo dall’altra parte, ha continuato de Canziani, non si può non ammirare il meraviglioso edificio angolare Sambolini-Plöch, che porta la prestigiosa firma dell’architetto triestino Emilio Ambrosini, sul cui spiccano i bovindi arricchiti dai deliziosi balconcini a forma di cesti, la quale custodisce l’ascensore più antico della Croazia (risalente al 1912), non più in funzione. Oltre ad avere pensato a tutto per ciò che concerne gli ornamenti, l’urbanista non ha mancato di incorporare alla facciata anche una ghirlanda di fiori che scende tra due vasi decorativi a movimenti semicircolari ed è sorretta da ambo i lati da due figure femminili, che vanno a incorniciare la finestra nella zona relativa al mezzanino. Inoltre, ha rilevato, vi si possono osservare i rilievi della madre con in braccio il bambino, caratterizzata da motivi vegetali sullo sfondo. Raggiunto l’uscio del palazzo, lo storico dell’arte ha fatto notare sopra di esso una stupenda conchiglia sulla quale poggia il balcone, affiancata da svariati pesci e calamari stilizzati collegati da fili che fanno pensare alle erbe marine, andando a creare un suggestivo momento che sa di mare. Riallacciandosi alle sue parole Arko Pijevac ha specificato che gli organismi nominati rappresentano molto probabilmente il rapporto dell’uomo con la natura e la conchglia è collegata alla Capasanta (pecten jacobaeus) o Pettine di mare, utilizzata spesso quale motivo ornamentale e simbolizzante la fertilità e la voluttuosità femminili.

Foto: ŽELJKO JERNEIĆ
L’incanto e il mistero di Casa Sirius
Altre creature magiche, a tratti raccapriccianti e fantastiche, sono scorgibili su quella che può venir considerata quale una tra le più esotiche e misteriose abitazioni signorili del capoluogo quarnerino, ovvero Casa Sirius, ubicata in via Ivan Dežman 3. La stessa fu costruita nel 1912, su progetto del noto architetto Giovanni Rubinich e grazie al sostegno finanziario dell’influente avvocato Salvatore Bellasich, per dar sede agli incontri della Loggia Massonica, di cui l’esperto era membro come molti altri imminenti personaggi fiumani (Andrea Lodovico Adamich, Giovanni de Ciotta, Paolo Scarpa, Frano Supilo, Milan Marjanović, Riccardo Zanella, Robert Whitehead e altri), il che ha completamente decretato il suo assestamento esterno, ispirato prevalentemente alla simbolica dei massoni. Su indicazione di Theo de Canziani il gruppo ha potuto contemplare che l’ingresso nell’edificio è incorniciato da un fregio decorato e fiancheggiato da mezze colonne scannellate (rappresentanti l’entrata nel tempio di Salomone) che, in combinazione con i due atleti situati nella lunetta, donano un aspetto monumentale e spirituale al portale. La maggior cura è stata data alla decorazione della facciata del pianoterra dove è stato realizzato, lungo tutto il palazzo, un nastro in rilievo composto da dettagli zoomorfi (delfini, balena, civetta, meduse, lucertola, serpente, creatura alata, leoni/agnelli), geometrici e numerologici (svastica, cuori, numeri, rebus) e floreali stilizzati (festoni di alloro). Per un osservatore inesperto, essi rappresentano solo un ornamento insolito che desta interesse, mentre per coloro che qui si radunavano per i loro rituali, avevano sicuramente un significato ben concreto e determinata importanza. In tale contesto, la biologa ha riferito che nel cristianesimo i motivi della balena e del delfino riportano sempre una simbologia positiva relativa all’uomo tradotta nella speranza, nell’amore, nelle connessioni amicali, come pure nel suo continuo interrogarsi sulla relazione con la natura e le metamorfosi dal male al bene, come ben esemplificano la leggenda dello Ionio e la storia di Pinocchio.
All’interno del palazzo, l’unico segno che va a confermare che si sia trattato di una sede massonica è la stella rossonera a cinque punte in un cerchio recante la scritta “Sirius”. È realizzata nel terrazzo dei vani ufficiali ubicati in uno dei due piani sotterranei e rappresenta il cosiddetto “Ouroboros” (simbolo antico dell’eternità, raffigurata da un serpente che si morde la coda). Vi si possono però anche osservare svariati ornamenti sul pavimento di terrazzo prestati dall’architettura antica.

Foto: GORAN ŽIKOVIĆ
Zammattio e le meraviglie di via Dolac
A seguire, guadagnando la discesa che accompagna il Primo ginnasio croato gli appassionati della storia cittadina, abilmente guidati dallo storico dell’arte, si sono soffermati all’inizio di via Dolac, già Via Clotilde, la quale spruzza storia e cultura da tutti i pori. “È difficile crederlo, ma fino al 1880 la zona era ricoperta da ampi orti e vigneti e il terreno era edificabile. Per tale ragione vi venne innalzato il magnifico palazzo neorinascimentale della Scuola femminile con insegnamento in lingua italiana “Emma Brentari” (in omaggio alla maestra, scrittrice e direttrice della stessa, nota con lo pseudonimo Dora Valle), al giorno d’oggi sede della Biblioteca universitaria. L’autore del progetto fu il giovane talentuoso architetto triestino Giacomo Zammattio, trasferitosi a Fiume nel 1884, il quale venne incaricato di elaborare anche quello relativo all’istituzione maschile, ovvero l’odierna Scuola media con insegnamento in lingua italiana (Liceo), sita alla fine dello spiazzo Dolac. Come testimoniato dalla data riportata sulla facciata occidentale, la posa del tetto della Scuola femminile “Emma Brentari” ebbe luogo nel maggio del 1887 e rappresenta uno degli edifici fiumani più moderni del XIX secolo.
Infatti, date le acque sotterranee e l’impossibilità di bonificare la base, Zammattio s’invento le fondamenta galleggianti o delle zattere, ha spiegato de Canziani, specificando che “all’entrata della sporgenza centrale collocò due identici portali, atti a far risaltare i due contenuti, quello dell’istituzione scolastica e dell’ Ufficio tecnico, di cui oggi se n’è conservato soltanto uno. Riallacciandoci alla tematica odierna, sempre alzando gli occhi al cielo, sono osservabili degli acroteri a conchiglia circondati da motivi vegetali e antropomorfi, come pure svariate composizioni floreali stilizzate che vanno a definire il palazzo”.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.