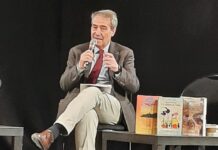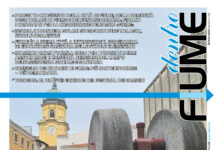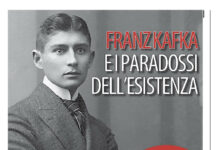Nel 1908 il monastero delle monache benedettine, sito nelle adiacenze della Chiesa dell’Assunta (Duomo) e annesso alla cappella di San Rocco (demolita nel 1914) si presentava in condizioni pessime, tantoché vi esisteva la reale probabilità che crollasse. Da quanto riportato dalla storica dell’arte Radmila Matejčić nello scritto “Come leggere la città”, dato che le suore non disponevano di mezzi sufficienti per la costruzione di uno nuovo, l’associazione religiosa umanitario-caritatevole “Maria”, guidata dal canonico mons. Mattia Balas, organizzò una raccolta fondi. Al contempo fu anche fondato il Comitato per l’edificazione del convento presieduto dall’ambiziosa ed energica moglie del governatore dell’epoca, il conte István (Stefano) Wickenburg de Capello, Sofia Pichler-Limpurg, il quale riuscì a racimolare le donazioni necessarie (da parte di privati e aziende) per l’acquisto di un ampio terreno, come pure quelle per l’innalzamento della struttura monastica. A detta del giornalista Goran Moravček (nell’articolo “San Rocco in Cittavecchia”, pubblicato sul sito www.fluminensia.org), prima dello smantellamento della cappella di San Rocco, sembra che Balas fosse riuscito a mettere in salvo l’antico organo, realizzato a Venezia nel XVIII secolo, e a cederlo per cento corone alla Chiesa della Beata Maria Candida del villaggio di Grižane-Belgrad (nella valle di Vinodol), consegnate in seguito alle benedettine per le spese del trasloco. Queste ultime non furono da meno e dalla vendita di svariati mobili, porcellane preziose, staffe in ferro battuto, vetri, maniglie e chiavi dei portoni della vecchia abbazia al Museo civico (conservati presso il Museo di Marineria e di Storia del Litorale croato) raccolsero 9.880 corone. Il trasferimento venne effettuato il 14 luglio del 1914.
I Poglayen
Il sunnominato terreno, ubicato nella parte settentrionale di Via Trieste (oggi via Franjo Čandek), precedentemente fu proprietà della rinomata famiglia Poglayen, il cui cognome è scolpito sulla colonna in pietra ubicata a sinistra dell’ingresso nella tenuta. Lo stesso, nello specifico quello di Giovanni Poglayen, viene menzionato nell’indice dei “negozianti all’ingrosso” e dei “magazzini di ditta” del 1793, nel quale si leggono anche quelli di Adamich Simone e Figlio, Bienenfeld Adamo, Cavalli direttore della fabbrica Potasch, Cragnez Francesco, Foresti Giovanni Batt. Direttore della Farica cuoj, Nais Gianbattista e Comp., Orlando Giuseppe direttore della Fabbrica cere, Pisanello Carlo e Figli, Plenario Giuseppe, Santarelli Santo e Comp, Sporer Andrea, Tomasich eredi, Wohinz vedova di Michele. Lo storico e traduttore Silvino Gigante (fratello di Riccardo) negli “Appunti sulle condizioni igieniche e sanitarie della Fiume d’altri tempi”, dà voce che successivamente, nel 1820, quale esecutore testamentario del dottor Felice (Felix) Segher de Weissenhard, viene nominato un certo Matija Poglayen, mentre nel 1864 fu eletto canonico di Fiume lo storico Josip Poglayen, autore dell’elenco degli ecclesiastici fiumani dal 1395 al 1879, consultato in seguito anche da Giovanni Kobler.
Architettura razionalista
Dopo aver fatto recintare il podere da un alto muro divisorio, il succitato canonico affidò il progetto relativo alla realizzazione del monastero all’impresa edile “Emilio Celligoi et Co”, nello specifico all’architetto austriaco Theodor Träxler affiancato dal progettista Eugenio Celligoi (i loro nomi sono osservabili ancora oggi su una delle pareti).
La pianta dell’imponente complesso fu pensata a forma di “E”, di modo che sul lato occidentale venisse collocata l’ala inerente agli ambienti conventuali e in quello orientale fossero siti gli spazi relativi alla scuola media superiore femminile. Nell’idearlo l’architetto viennese, formatosi sulle basi dell’Art Nouveau, si ispirò senza dubbio alla scuola del collega tedesco Josef Hoffmann, uno dei più importanti pionieri dell’architettura e del design del XX secolo, il cui stile era caratterizzato dalla chiarezza, dalla semplicità geometrica, dalla sobrietà, dall’eleganza, dalla raffinatezza, dalla bizzarria e dall’equilibrio. Ispirato dal movimento inglese e scozzese “Arts & Crafts”, teso a infondere arte in tutti i settori della vita, era convinto che la stessa potesse addirittura “guarire” l’animo umano.
L’architettura fu concepita in stile razionalista e vi furono applicati gli standard igienici e generali più alti e moderni dell’epoca, tantoché veniva considerato uno dei monasteri benedettini più moderni della Monarchia. In luogo del tradizionale chiostro porticato, furono realizzati corridoi con ampie finestre vetrate, riprese anche ai piani superiori e l’intero edificio fu innalzato di modo che nel corso di tutta la giornata venisse illuminato dal sole.

Foto: ŽELJKO JERNEIĆ
La Chiesa di San Giuseppe
A detta di Matejčić, le circostanze relative alla guerra impedirono l’edificazione della parrocchia nell’ambito del nuovo luogo di contemplazione, ma ciò non impedì allo scrupoloso mons. Balas di continuare ad adoperarsi per il completamento del complesso. Infatti, vent’anni dopo, nella data del 29 dicembre 1929, fu poggiata la prima pietra della Chiesa di San Giuseppe e il 30 ottobre del 1931 ebbe luogo la sua inaugurazione (di cui riportò il quotidiano La Vedetta d’Italia). La stessa fu progettata dall’architetto lussignano Eduardo Stipanovich, giunto nel capoluogo quarnerino per fondare la sua impresa edile a seguito degli studi presso la Scuola Industriale Superiore di Trieste (una delle cinque istituzioni della Triest KK Staats Gewerbeschule o “Scuola Industriale dello Stato”, oggi Istituto Tecnico Statale “A. Volta”) e l’abilitazione a Zara, il quale si servì del disegno originale risalente al 1912. All’inizio del 1949 le suore benedettine di Fiume optarono per l’Italia e l’abbazia venne nazionalizzata dallo Stato jugoslavo, che in seguito vi aprì la Casa dello studente.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.