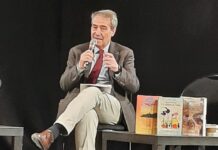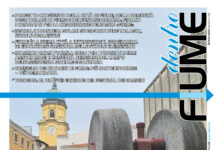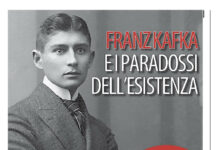Nell’occasione del Giorno del Ricordo Johnny Bertolio ha tenuto una conversazione con un gruppo di studenti di Monfalcone e la presentazione della sua ultima opera “Sottostorie” alla libreria Ubik di Trieste. Prima di tutto diciamo chi è Johnny Bertolio. Diplomatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa e conseguito il PhD all’Università di Toronto, ha maturato una variegata esperienza nella didattica dell’italiano. Attualmente collabora come autore, formatore e redattore nell’ambito umanistico con la casa editrice Loescher, per cui ha pubblicato tra l’altro “Controcanone: la letteratura delle donne dalle origini ad oggi” e quest’anno appunto “Sottostorie”.
Studiare le discipline da un’ottica diversa
Il suo è un diverso approccio alle materie umanistiche, in particolare alla storia. “Si tratta di cogliere aspetti che ci sfuggono – ha affermato alla Ubik – di essere più critici rispetto a quello che abbiamo studiato e quello che si racconta. In Controcanone esplorai l’avverbio contro, descrissi le esclusioni in letteratura: a scuola si tende a perpetuare alcuni scrittori, da Dante a Macchiavelli, da Carducci a Manzoni, non solo perché scrivevano bene, ma anche perché corrispondevano ad un criterio politico, quello del risorgimento in particolare; quel canone ha escluso ad esempio le donne. Il sotto indica che sotto la storia vivono altri fenomeni che sono stati fisicamente rimossi dalla scrittura, dalla storia e dal potere: il potere ha cancellato o emarginato ciò che non gli si confaceva: donne, persone di etnia non dominante, schiavi e schiave, le minoranze queer, le malattie fisiche e mentale”.
Le frontiere italiane nel ‘900
A Monfalcone Bertolio ha incontrato cinque classi Quarte dell’Istituto Michelangelo Buonarroti per una lezione sulla letteratura dell’esodo. “Uno dei capitoli di Sottostorie – ha raccontato Bertolio – è incentrato sulle frontiere italiane nel Novecento dal primo al secondo dopoguerra, con una trattazione organica della storia dell’Istria, della Dalmazia e di Fiume dal trattato di Campoformio del 1797 al trattato di Osimo nel 1975. Insieme con i saggi di storici importanti, che hanno studiato le vicende di queste terre prima e durante il fascismo, gli infoibamenti, gli opposti nazionalismi, il capitolo di ‘Sottostorie’ include anche brani di testimoni: Paolo Santarcangeli, sulla Fiume del primo Novecento, il modernissimo testo della Carta del Carnaro del 1920, attribuito ad Alceste de Ambris, e ancora Marisa Madieri e Anna Maria Mori su esuli e rimasti. Ho scelto Santarcangeli perché mi piacciono gli autori in cui si vede che lo scrittore non corrisponde ad una certa classificazione, ma è più complesso. Santarcangeli è fiumano, è ebreo, ha il mondo slavo alle spalle, la sua esperienza di vita non richiede una scelta di campo, poi è costretto ad incasellarsi dalla situazione del momento”.
L’incontro con Konrad Eisenbichler
La moderatrice alla Ubik, Rosanna Turcinovich, gli ha chiesto come sia venuto a conoscenza personalmente della storia del confine orientale. Bertolio ha ricordato che, essendo vissuto per un periodo a Toronto, ha conosciuto Konrad Eisenbichler, suo insegnante universitario, esule lussiniano, attraverso il quale è venuto a contatto con le storie dell’esodo istriano, fiumano e dalmato. Ha conosciuto le famiglie di coloro che possono essere definiti a ragione esuli due volte perché, abbandonando la proprio casa e emigrando all’estero, hanno perso forzatamente terra e lingua.
Un manuale per insegnanti
“Scrivo libri per insegnanti – ha proseguito – per mettere in circolazione brani di scrittori che li aiutino nella didattica, per avere una lettura più completa della storia che insegnano. I 14 capitoli del libro raccolgono quelle storie plurali di ‘margini, oppressioni, riscatti’ spesso finite dimenticate nel racconto storiografico tradizionale, canonico, soprattutto a scuola. Il fascismo nel 1938 promulgò il manifesto della razza, che non era solo una questione etnica, ma identificava i valori nei quali racchiudere l’unione tra uomo e donna, si schierava contro omosessuali, neri e malati. In questo periodo ci fu un’impennata di internamenti; le fonti i documenti privati, diari, lettere, foto e documenti giudiziari indicano questo. Si ricordi che chi veniva internato in manicomio aveva automaticamente la fedina penale sporca e la vita distrutta conseguentemente. Dopo la Shoah si usa con molta cautela la parola genocidio, ma molto simili furono i massacri di armeni, tibetani, curdi, nativi americani e tanti altri. Le violenze però portarono alle rivendicazioni dei diritti come il movimento del femminismo, di liberazione sessuale, il black power, che crearono consapevolezza e riscatto”.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.