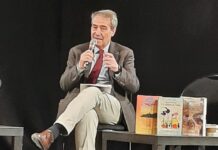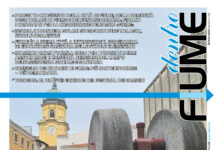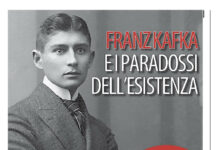Si celebrano quest’anno le nozze di diamante tra il MIQ e la sua gente, da sessant’anni fedele alla più antica competizione musicale itinerante tuttora esistente.
Era il 22 maggio 1964 quando al Teatro Fenice di Fiume – all’epoca cinema Partizan – Dunja Rajter inaugurava la prima edizione di quello che nasceva come “Melodije Kvarnera” e che vedeva in gara nomi importanti come Ana Štefok, Višnja Korbar, Vikica Brešer, Toni Kljaković, il duo Kvarner, accompagnati dall’orchestra diretta da Zlatko Černjul e dal gruppo “Uragani”. Proprio Ana Štefok, che stava vivendo il suo periodo d’oro, fu la prima vincitrice con la canzone “Nade”, mentre nel 1965 fu il turno di una star come Arsen Dedić. Saranno invece Ljubo Jelčić, Ksenija Urličić e Raniero Brumini a condurre molte delle edizioni successive.
Gli anni ‘60 e l’avvento del ciacavo
Inizialmente i brani in gara erano in croato standard, ma dal 1966 il ciacavo irrompe al festival, vinto da una delle sue canzoni-simbolo, “Bokaleta”, proposta da Ira Kraljić e Dinko Banić e scritta dal grande Nello Milotti. Nello stesso anno debuttano due future protagoniste della musica croata, Radojka Šverko e Lidija Percan, che da allora hanno preso parte al festival in tante occasioni. Non tutti i partecipanti hanno ottenuto la loro stessa fortuna ma sono moltissimi gli artisti che, grazie al MIQ, hanno avuto la possibilità di emergere e di ritagliarsi uno spazio significativo nella scena musicale nazionale o regionale.
Il legame con il territorio diventa sempre di più una delle peculiarità della manifestazione: sempre nel 1966 il festival inizia a essere strutturato su tappe come il Cantagiro italiano, una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto da tutti gli altri festival jugoslavi e che ha costantemente alimentato l’affetto del pubblico. Sono più di 400 le serate che si contano fino a oggi, in viaggio tra le città e i comuni dell’Alto Adriatico.
Nel 1969 “Melodije Kvarnera”, ormai punto di riferimento musicale di entrambe le regioni, assume l’attuale denominazione di “Melodije Istre i Kvarnera” su proposta di Alverna Smokvina, che in precedenza aveva lavorato anche per La Voce del Popolo e che nel 1972 diverrà l’illuminata direttrice e organizzatrice del festival, ruolo mantenuto per ben quattordici anni.
La presenza del bilinguismo
Nel frattempo fanno la loro apparizione i primi titoli bilingui, oppure interamente nella lingua di Dante o in istroveneto, e in alcune località la conduzione si tiene anche in italiano. Nel 1971 Ljiljana Budičin-Manestar e Mirko Cetinski conquistano il secondo posto con “Che bel, che bel, che xe”, raggiungendo poi il terzo posto nei due anni successivi con “Amor de pescador” e “Insieme in riva al mar”, tutte scritte da Mario Kinel e diventate, tra ironia e doppi sensi, dei classici delle estati degli anni Settanta sul litorale. Ljiljana Budičin-Manestar è la principale rappresentante della comunità italiana al festival: è seconda nel 1978 con “La partidina”, nel 1981 vince in coppia con Angelo Tarticchio con “Andemo in barca”, lancia successi come “Contrada” e “Ciacole”. Nel 1983 la vittoria arride invece a Lidija Percan che presenta un altro divertente pezzo di Kinel, “Con lui in motocicleta”.
Tanti i protagonisti del “vecchio MIQ”, come è chiamato il primo periodo del festival tra 1964 e 1986: oltre a Lidija Percan, Ljiljana Budičin-Manestar, Mirko Cetinski e Angelo Tarticchio, impossibile non ricordare Toni Kljaković, Roland Šuster, Ira Kraljić, Lada Kos, Beti Jurković, Nevia Rigutto, Aldo Galleazzi, i “777”, Milka Čakarun Lenac. A quest’ultima si lega quello che è diventato l’inno del MIQ, “Ča je ča”: quando fu presentata nel 1975 non vinse nessun premio, ma il suo ritornello era destinato a restare nel tempo.
Tanti anche i brani indimenticabili che continuano a solcare le onde delle radio fiumane e istriane ancora oggi: “Riko moja”, “Školjka”, “Urinjska baklja”, “Kartulina z Kraljevice”, “Ognjišće”, “Kupil san ti prstenac”, “Trsački prošijani”, “Lipo j’ vino pit”, “Nebuloza”, “Moj Kastav”, “Frane Merikan”, “Ča smo mi”, “Pisma MIK-u” e quella “Barke Faren” che Beti Jurković ha portato fuori dai confini regionali per farne uno dei suoi grandi successi.
La crisi di fine anni ‘80
Il MIQ è stato fucina di talenti anche tra compositori, autori e musicisti, tra i quali Nello Milotti, a cui oggi è intitolato il premio al brano che meglio rappresenta la tradizione locale, e Ljubo Pavešić, a cui è stato a lungo dedicato il premio al miglior testo.
Nel 1986, però, nel pieno della crisi economica e sociale della Jugoslavia federale, arriva quello che appare come il canto del cigno. Il pubblico affolla le piazze del festival come sempre, ma il filo si spezza. Anche se la musica mantiene un grande rilievo e tante stelle della canzone continuano a splendere nei cieli della Croazia di fine anni Ottanta, altri sono i pensieri e le priorità. La realtà, le sicurezze, le abitudini consolidate da decenni si stanno sfaldando. Il viaggio del MIQ si ferma, ma non sarà per sempre.
La rinascita
Il 15 giugno 1991, dieci giorni prima della dichiarazione di indipendenza di Croazia e Slovenia, Fiume festeggia San Vito con una retrospettiva dedicata al MIQ che riunisce tutti i protagonisti del “vecchio” festival nella piazza gremita davanti alla cattedrale. Le paure di un conflitto imminente serpeggiano, ma si affacciano all’orizzonte anche le speranze di un futuro diverso, una nuova pagina di storia sta per essere scritta: c’è la voglia di ricominciare e anche per il festival l’entusiasmo della serata è un impulso decisivo per la rinascita.
Il grande momento arriva nel 1993: il 15 giugno, nel magico scenario dell’Arena di Pola, il festival riapre i battenti dopo sette anni con un cast che mescola esperienza e novità: Vesna Nežić Ružić (che a oggi vanta il record di ben 27 partecipazioni), Mirko Cetinski, Angelo Tarticchio, Marinella Malić fanno da traghettatori tra il vecchio e il nuovo MIQ, accompagnando l’esordio di tanti futuri protagonisti come Joso Butorac, Duško Jeličić, Jozefina, Đani Maršan, Sergio Pavat, Elio Pisak e un giovanissimo Toni Cetinski. Il successo delle serate e quello riscosso in seguito da canzoni come “Adio bionda”, “Santa Eufemia” e “Roža, roža” lascia subito intuire che non si tratta di un fuoco di paglia ma dell’inizio di una nuova esaltante avventura.
Convinti fautori del ritorno del MIQ sono Andrej Baša e Milka Čakarun Lenac, sulla scena musicale fiumana e croata fin dall’inizio degli anni ‘70. Sono i tempi del grande ritorno di Radojka Šverko, che regala perle come “Nišan šla za ten”, “Va dihe mora”, “Bracolet”; del debutto della regina del MIQ, Karin Kuljanić, che ha collezionato finora cinque vittorie; dei pezzi divertenti di Battifiaca, Elio Pisak e dell’accoppiata Pavat/Nežić Ružić; delle presenze di star della scena nazionale come la grande Tereza Kesovija o come Vinko Coce, che nel 1997 interpreta il maggior successo della storia del concorso, “Vilo moja”.
Valorizzazione dell’identità locale
Il festival contribuisce in maniera determinante al fenomeno del “Ča-val”, l’onda del ciacavo che travolge l’Istria e il Quarnero valorizzando l’identità locale anche attraverso l’uso del dialetto nella musica. Diversi artisti e gruppi raggiungono fama nazionale scrivendo e cantando “nella lingua di casa” e tutti, prima o poi, salgono sulla carovana del MIQ: i “Gustafi” e Šajeta, fino a una delle colonne del festival, Alen Vitasović, che nel 1995, alla prima di una lunga serie di presenze, vince il premio del pubblico con “Samo Bog te moga učiniti”, uno dei tanti successi nati dalla collaborazione con l’amico Livio Morosin.
Una carovana che costituisce l’elemento distintivo più visibile del MIQ: il fatto che ogni giorno siano previsti spostamenti da una cittadina ospitante all’altra crea un clima impensabile nelle altre gare canore. Per un paio di settimane, organizzatori, cantanti, musicisti, tecnici, giornalisti si muovono insieme in pullman, in colonne di auto colorate o sui traghetti per raggiungere le isole. Non vuol dire che la competizione non sia sentita, anzi, vincere è questione di prestigio perché significa avere raccolto il consenso del pubblico, visto che il sistema, come nel passato, resta quello di raccogliere i voti degli spettatori serata dopo serata, mentre aumenta il numero dei premi attribuiti dalla giuria degli esperti a riconoscere la qualità dei brani. Ma a prevalere è l’atmosfera spensierata e conviviale che si crea: in ogni sede l’arrivo del MIQ è una vera e propria festa con spettacoli, sfilate, marce bandistiche, mercatini e banchetti gastronomici. La carovana del festival è occasione per conoscersi, stringere amicizie, avviare rapporti professionali tra un piatto di fusi e una bottiglia di terrano. Tutti ci vogliono essere, il MIQ diventa il piccolo Sanremo della regione ma anche un angolo felice in cui continuare a coltivare la passione per la musica locale.
Nel nuovo millennio
L’ingresso nel nuovo millennio si presenta abbastanza tortuoso: nel 2000 la collaborazione tra Andrej Baša e Milka Čakarun Lenac si interrompe. Milka fonda “Melodije Kvarnera”, che si svolge per quattro anni tra 2001 e 2004, mentre Andrej si prende un anno per riorganizzare la manifestazione e riavviarne il cammino nel 2002 con rinnovata energia. I 60 anni dalla nascita non corrispondono dunque alle edizioni realizzate: la pausa tra 1987 e 1992 e quella del 2001, infatti, portano il totale a quota 54.
Andrej Baša è tuttora il “papà” del MIQ, una vita dedicata al festival con la capacità di restare sempre al passo coi tempi, mantenendo saldo il legame con la tradizione ma senza nostalgie, con lo sguardo aperto a ogni genere musicale perché anche il rock, il metal, il rap possono raccontare la realtà attraverso i dialetti. Miscela perfetta anche quella realizzata sul piano generazionale: i veterani tanto amati dal pubblico non mancano mai e a quelli presenti nelle primissime edizioni degli anni Novanta vanno ad aggiungersi i ritorni di Voljen Grbac, Lidija Percan, Nevia Rigutto, Francesco Squarcia e i debutti di Vivien Galletta, Mladen Grdović, Mirjana Bobuš, Daniel Načinović. Ma al loro fianco è sempre più ampio lo spazio dedicato ai migliori giovani della regione: Karin Kuljanić, Tamara Brusić, Gina Picinić, Alen Polić, Sabrina Hebiri, Damir Kedžo, Marko Tolja, Božidarka Matija Čerina, Katja Budimčić, Lado Bartoniček, Antonio Krištofić, Gianluca Draguzet, Erik Balija, Martina Majerle, Nina Fakin, Andrina Frleta, Daniel Moscarda, Tedi Grubica e altri ancora. Un eccezionale elenco di talenti che devono al MIQ una parte consistente della loro fortuna. C’è chi vi trova il proprio palcoscenico ideale, chi da qui spicca il volo verso altre affermazioni e anche chi compie il percorso inverso: sono diversi i nomi celebri sbarcati nel golfo del Quarnero nel corso degli anni (al MIQ ad esempio deve i suoi primi grandi successi Lidija Bačić tra 2009 e 2011) e curiosamente alcune delle hit più recenti sono state portate da artisti provenienti dalla vicina Slovenia, gli Atomik Harmonik, Darja Gajšek e soprattutto Luka Basi, che nel 2018 con “Istrijanko ružo moja” ha stabilito il record di visualizzazioni per un brano pubblicato al MIQ, a oggi addirittura 16 milioni. Numeri impressionanti ben lontani da quelli consueti, visto che il rapporto così stretto con il territorio e con il dialetto mantiene la popolarità dei brani nell’ambito dei confini locali: ma è proprio questa una delle chiavi della vitalità del festival, non avere mai venduto l’anima al commercio all’inseguimento della notorietà a tutti i costi, e ciò nonostante avere assunto un significato iconico.
Vittorie e collaborazioni
Iconica è la carovana del MIQ. Iconica è la scala istriana, patrimonio immateriale dell’Unesco, elemento imprescindibile di tante melodie. Iconici sono i volti dei presentatori, soprattutto quelli dell’irresistibile coppia Mario Lipovšek Battifiaca e Robert Ferlin, quest’ultimo al timone fin dal 1993. Iconiche sono, naturalmente, le canzoni. Difficile scegliere le più rappresentative tra le centinaia che sono andate a comporre, anno dopo anno, il mosaico del MIQ. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta “Večeri boje naranče” o “Neću kuhat, neću prat”, “Barka lipog imena” o “Dižen sidro”? O in tempi più recenti, quella “Da bimo i k letu” con cui Nevia Rigutto, Duško Jeličić, Tamara Brusić e Mauro Staraj nel 2021 hanno unito le forze conquistando insieme le loro prime vittorie personali e diventata con la sua allegria l’emblema della sfida vinta dal MIQ anche sulla pandemia, con due edizioni molto complesse spostate a settembre ma ugualmente portate a termine con successo.
Eppure il rilievo che il festival ha assunto dal suo ritorno non lo ha portato a monopolizzare la scena. Al contrario, ha avuto una funzione di stimolo alla nascita di nuove manifestazioni, sia quelle consacrate al ciacavo (come “ČAnsonfest”, che si tiene con successo a Castua dal 2005 e che si contraddistingue per lo stile chanson e per un’attenzione particolare alla qualità testuale, e “Grobnička skala”, ideato dalla compianta Vlasta Juretić, riservato alle voci nuove e svoltosi a Čavle dal 1998 al 2018), sia quelle riservate alle parlate romanze: “Dimela cantando”, nato nel 2013 all’interno del Festival dell’Istroveneto di Buie, ‘Na cantada nsembro, inserito dal 2019 nel programma del Festival dell’Istrioto, e ora anche Canzonette fiumane. Un quadro ricco e variegato che costituisce uno straordinario unicum non solo in Croazia e che ha un ruolo fondamentale nella perpetuazione dei dialetti e delle lingue minoritarie come codici vivi, dinamici e utili. Viva il MIQ e auguri di altri 60 (come minimo) di questi giorni!
*docente ed esperto di musica locale
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.