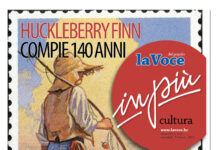Un’intellettuale appassionata, Giuseppina Martinuzzi (1844-1925), è un personaggio che ben racconta i confini di un mondo complesso come quello istriano. Il suo nome però appare raramente nella comune percezione della storia, se non nel corso di convegni scientifici specifici. Eppure si tratta di una donna che ha lasciato il segno.
“La passione politica e l’amore per la cultura: queste sono, a mio avviso, le cifre preminenti di una donna complessa, diversa, e forse fondamentalmente sola, non sufficientemente capita e valorizzata neppure dai compagni di strada coevi, tra fine Ottocento e inizi del Novecento”. Così ne parla la storica Silva Bon, che se ne è occupata in varie occasioni, anche partecipando agli incontri ad Albona. La città natale della Martinuzzi continua ad occuparsi del suo pensiero, ponendola al centro di studi e conversazioni. Ma è uno spazio circoscritto. Cosa si dovrebbe sapere di questa socialista, insegnante a Trieste, autrice di saggi, poesie e tanto altro?
“Sarebbe giusto capire e valorizzare – risponde Silva Bon – lo sguardo consapevole e realistico alla condizione umana, maschile e specialmente femminile, intorno a lei; il credere nel potere liberatorio, affrancatore ed emancipatore della conoscenza e dell’acculturazione; l’impegno nella prassi attiva, quotidiana, indefessa, volta al cambiamento; l’ispirazione poetica lirica che si traduce debordante anche nei testi in prosa; l’enfasi del vissuto personale riverso nella lotta sociale e di classe”.
Viene spesso definita una donna che anticipa, che precorre i tempi, e diventa emblema di modernità. Per quali ragioni?
“Per l’estrema generosità del suo animo, per quell’amore che lei riversa sui più deboli, i più fragili, i subalterni, e in particolare sulle donne, ancora tenute in stato di soggezione dagli usi e costumi imperanti; dalla legislazione in vigore; in un rapporto, una relazione di squilibrio e sudditanza generalizzati. Lei sfida da sola, forte, autonoma, indomita, ogni pregiudizio e attacco personale, mossa da una fede nel progresso, nella necessità di cambiamento, che le danno sicurezza, slancio, energie di fare e di impegnarsi per la causa sociale, di indirizzo politico socialista e poi comunista, in cui crede”.
Ma quali sono le sue esperienze reali nei primi decenni del Novecento?
“Conosce la vita al limite della gente delle miniere, là ad Albona, nella vicina Arsia; conosce, visita e tocca con mano la realtà dei quartieri più degradati economicamente e moralmente a Trieste, dove lavora nel mondo della scuola primaria”.
Che cosa diventa per lei la letteratura?
“Viene usata da Giuseppina Martinuzzi come un’arma: la sua arma personale, ben affilata e capace di colpire e ferire, che le è consona. Lei è un’intellettuale integrale. Esalta con nobiltà d’animo la fortuna di nascere da una famiglia borghese di Albona, cresce in un ambiente colto, aperto alle sue esigenze culturali, ai suoi interessi e propensioni didattici. Giovanissima assorbe le idee politiche del suo ceto, italofono e irredentista: le è mentore e maestro lo storico e cultore di storia patria Tomaso Luciani, che la spinge a esprimersi in favore di un possibile ricongiungimento all’Italia, con rivendicazioni nazionali e opzioni politiche che si ricollegano al Risorgimento italiano e alle lotte di Redenzione dell’area giuliana, triestina e istriana. Scrive testi poetici, racconti, prose d’arte come se fossero tutti interventi impegnati, finalizzati ad uno scopo non squisitamente letterario, bensì molto pratico, pragmatico, immediato. Alla stessa stregua i suoi discorsi politici sono pagine letterarie, vibranti di passione, di umanità,”.
A cosa la porterà la maturazione di donna impegnata?
“Negli anni della maturità, la conversione ideale alle idee socialiste risponde a esigenze insite nel suo carattere, fortemente sensibile alle istanze dei più poveri, dei più bisognosi. La lotta di classe viene fatta propria da Giuseppina Martinuzzi, attraverso la sua formazione autodidatta e la lettura critica dei testi classici di Marx e di Engels. Per questo suo attraversamento di campo politico viene fortemente redarguita dagli ex compagni di strada, che le imputano come un tradimento del proprio ceto e delle opzioni nazionali, il passaggio alla parte socialista e dopo il 1921 la radicalizzazione alla parte comunista”.
Come considera a quel tempo la condizione femminile?
“Ne ha una visione lucida, proprio perché lei stessa ha pagato un prezzo altissimo per le proprie scelte personali controcorrente. Le donne devono compiere un percorso di emancipazione, di liberazione, per conquistare autonomia e indipendenza, così materiali, come intellettuali. Il suo pensiero si volge alle possibilità offerte dall’acculturazione, soprattutto, e dalla nascita di nuovi rapporti tra uomini e donne, rapporti basati sulla sostanziale parità, sul rispetto reciproco. In nome della visione di un auspicato futuro rivoluzionario lei si rivolge spesso non solo alle donne, ma anche agli uomini, soprattutto ai giovani, per educarli alle nuove idee politiche, alle prospettive di nuove relazioni più equilibrate tra i sessi”.
Come va letta oggi Guseppina Martinuzzi?
“Non è un’operazione culturale semplice, o facile e piana. I suoi versi risentono dell’utilità politica che li riconduce ad essere un mezzo, un medium di comunicazione simile ad un’arma. I suoi componimenti poetici sono legati alla retorica dei tempi, alla necessità di cadere, di essere contenuti in strutture metriche, in generi letterari, che suonano obsoleti alle nostre orecchie.
Pertanto i suoi testi, anche prosastici, vanno contestualizzati, vanno letti come un documento, un documento storico e letterario. È necessario capire quello che sta dietro l’enfasi dell’ispirazione: tutto un mondo in cammino verso una progressiva visione della vita …”.
È l’autenticità del suo approccio che affascina ancora oggi?
“Direi che in Giuseppina Martinuzzi va premiata la sincerità dell’afflato poetico, l’originalità che la muove in prose che colpiscono la nostra fantasia e la nostra sensibilità di lettori moderni per la forte descrizione realistica: sono dei “J’Accuse” deliberati e strazianti, che ci fanno leggere la tensione della contrapposizione di classe negli anni dei fasti dell’età del positivismo e della spensieratezza della Belle Epoque. I suoi racconti sono delle denunce volute dell’arretratezza e della miseria in cui sono condannati a vivere, là, dietro l’angolo della prossima via, nei ghetti di periferia, nelle strade abbandonate, tanti bambini invisibili, tante donne denutrite, tanti uomini senza speranza”.
Insomma, la sua poetica sembra faccia paura…
“La poesia, la narrativa, i discorsi politici di Giuseppina Marttinuzzi sono percepiti come un grosso pericolo dalle autorità fasciste al potere, ancora quando, lei ultraottantenne, si ritira nella natia Albona, per concludere serenamente, ma coerentemente la propria vita. Perché le sue idee sono assolutamente innovative, originali, addirittura scandalose, lei è una anticipatrice, una visionaria, potremmo definirla, eppur ben calata nella realtà contingente dei suoi anni, gli anni in cui le è toccato di vivere, sono quelli che portano e preparano alla nascita del fascismo in Italia e delle aberranti tesi totalitarie in Europa”.
Si può dire che siano indicativi i titoli stessi delle sue liriche?
“Assolutamente, a partire da Ingiustizia. Canto storico politico, ad esempio. Oppure: Alle madri italiane dopo Amba Alagi. E ancora: Il lavoratore alla spada. Azione scenica; La spada degli oppressori; Invito alla luce; Presente e avvenire; Inno del XXV Anniversario della Società Operaia Albonese …Mi sembra che giustamente si discosti da questa prassi consolidata di poesia d’occasione, il carme conosciuto come La rondinella istriana, la prima strofa è fortemente godibile, scorrevole e senza forzature nelle rime baciate: O rondinella dalla penna nera/ che voli al mio balcone innanzi sera,/ io ti ravviso al caro pigolio// che sei venuta dal paese mio;/ da quel paese che al Quarner confina/ e che dall’Alpe al Promontor s’inchina./ O rondinella dalle ardite imprese/ narrami ciò che sai del mio paese./ …”.
E non è tutto qui, meritano uno studio approfondito e scientifico le sue tavole sinottiche, da maestra che non si smentisce e vuole educare: sono chiare, sintetiche, pragmatiche, raccolgono in schemi paragrafati da parentesi tutto lo scibile umano. Ma se ne parla poco, in un mondo in cui gli “ismi” vengono rivalutati in modo altalenante spesso si perde consapevolezza di ciò che va buttato e ciò che invece deve diventare un riferimento per tutti.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.