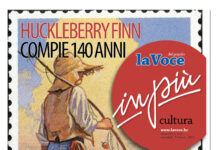Il contadino, il compare, la moglie, l’amante, l’amante-compare, la truffa, le mille peripezie e acrobazie morali, la soluzione, la commedia. Una commedia che sa d’amaro però, lucidissima nel fotografare la pochezza dell’uomo, la bassezza dell’impulso, la piccineria delle anime, l’egoismo, la violenza dei rapporti sociali, la condizione grottesca della vita. “La Moscheta” di Angelo Beolco il Ruzzante è diventata così la “Furbacchiona”, o meglio “Furbaćona”, con protagonista una Marijuča come tante, né meglio né peggio delle altre, il marito, un povero diavolo dell’entroterra che chiamano Pepić, il compare, che risponde a un soprannome crudo come quello di Žvane, il Marinaio (Trieštin), e naturalmente il Villano del prologo alias Škovacin, ma uno di quelli che ci vede bene perché osserva e ragiona, per cui arriva a concludere che l’uomo non ha colpa né pena se pecca: se pecca, e pecca sempre, è perché la sua Natura è più forte della sua cultura, perché, checché ne dicano i saggi, la volontà sarà anche la forza motrice suprema dell’umana natura, ma è lungi dall’essere una volontà libera.
La seconda versione della commedia
Il Teatro Popolare Istriano di Pola ha portato nuovamente in scena “La Moscheta” del Ruzzante nella strepitosa versione croato-ciacava di Branko Lučić. Per la sua seconda versione sono stati scritturati Valter Roša, Rade Radolović, Luka Mihovilović e Lara Živolić. Gli attori sono cambiati ma non il regista, e questo è un bene. Jasminko Balenović aveva diretto anche la prima versione della commedia, undici anni fa, e firma ora la regia della seconda che ha suggellato il successo dell’illustre precedente. Vista la reazione del pubblico, il remake potrebbe facilmente superare il prototipo in coppe e allori. Gli inviti si moltiplicano, il numero delle rappresentazioni cresce, la compagnia raccoglie la soddisfazione dei primi premi e il regista gongola. Gli abbiamo strappato un’intervista tra uno spettacolo e l’altro per parlare, naturalmente, di teatro e dintorni.
Voglio chiederle subito il perché di questo successo che dura nel tempo, perché mi sembra in contrasto con buona parte della produzione nazionale, condannata in partenza all’oblio. Ho in mente un regista di prestigio. Ogni anno mette in scena la storia di un’eroina classica che ama o odia fino al parossismo: la tragedia è venerata dalla critica, lo spettacolo fa incetta di premi, alla prima seguono due o tre repliche ed è fatta: lo spettacolo è morto e sepolto nel giro di una stagione se non prima. Nessuno ne parlerà oltre, nessuno chiederà il bis.
“Vede, il teatro è sempre la sintesi di un contesto: di un luogo, di un tempo, di una società. Bisogna confessare che il nostro contesto è irreparabilmente limitato, anche in termini puramente materiali: siamo un Paese piccolo, di dimensioni modeste, e lo spazio culturale riflette necessariamente queste dimensioni, sicché i testi dei nostri stessi autori, oppure gli adattamenti di autori stranieri, anche dei classici, vengono portati in scena ma poi non superano l’esame del tempo che passa: non reggono il giudizio inesorabile della posterità. Veramente gli esempi si sprecano, anzi direi che sono pochissimi i pezzi destinati a durare nel tempo e meno ancora quelli che si possono rappresentare ugualmente in località e regioni diverse dal luogo d’origine. ‘Furbaćona’ è a sua volta figlia di questo contesto e certamente ne condivide la sorte, ma in parte vi si oppone con tenacia. Bisogna innanzitutto dire che lo spettacolo è la riduzione di un classico del teatro italiano e mondiale: in realtà si tratta della prima commedia moderna. Moderna nel senso di epoca storica, se pensiamo che l’età moderna ha inizio con la letteratura rinascimentale e la commedia dell’arte, che a sua volta sono il terreno di coltura di quella che oggi chiamiamo semplicemente arte drammatica moderna.
Effettivamente è stata una grande sfida ripescare questa commedia allestita dieci anni fa e con successo, rifare tutto da capo, con un nuovo cast, nuove soluzioni interpretative e nuovo slancio, ancorché facendo tesoro dell’esperienza maturata nel primo allestimento. Ovviamente sapevamo quello che stavamo facendo: il testo di Branko Lučić che ha tradotto ‘La moscheta’ in dialetto istriano nella sua variante microlinguistica di Lindaro è un gioiello in sé, è materia vivente. La sua traduzione è fedele all’originale eppure Lučić gli conferisce un ché di personale e di autentico, vi aggiunge una dimensione locale in termini materiali ma anche psicologici. Sicuramente la sua traduzione e l’adattamento dell’originale al microcosmo istriano sono stati un fattore propiziatore per il successo della rappresentazione. Il dialetto, la lingua come retaggio immateriale, è un custode del teatro in quanto luogo d’incontro. È vero, il teatro è il prodotto di un determinato momento, tutto finisce con l’ultimo applauso, eppure è un polo d’attrazione per un vasto pubblico, a differenza di altre arti, senza nulla togliere alla poesia, s’intende. Il teatro è vivo, è vita. Il pubblico vede e sente l’uomo che recita in quella lingua, il contatto è diretto, immediato. Ovvio che poi la dimensione artistica s’intreccia a quella del divertimento nudo e crudo, come nel Rinascimento la stessa commedia dell’arte fu intrattenimento leggero nel senso odierno di entertainment, non meno che arte a tutti gli effetti. Ecco questi sono i motivi del successo di ‘Furbaćona’, che resiste al confronto con il passare del tempo, ed è come una tappa fondamentale per noi registi: ognuno di noi prima o poi nella vita conosce la ‘Moscheta’, se non all’università, in ogni caso in un momento successivo della sua carriera”.
Anche la Commedia italiana del Rinascimento muove però dalla più dichiarata imitazione: gli umanisti italiani non poterono che ricorrere a quel Plauto e a quel Terenzio che avevano a loro volta ridotto e “contaminato” i Greci. Si ebbe così un’imitazione dell’imitazione, come spesso avviene nelle arti, certo non senza innovazione ed evoluzione.
“Il teatro moderno si occupa poco della commedia antica, che è semplicemente subordinata alla tragedia per presunto difetto di dignità e valore. Aristotele dedicò la sua ‘Poetica’ alla tragedia, ovvero a quello che oggi chiamiamo il dramma, mentre una simile dissertazione per la commedia non è esistita anche se Umberto Eco sostenne che ci fosse stata ma andò distrutta. Ad ogni modo l’evoluzione e l’affermazione della commedia nel corso del Rinascimento ha avuto una sua gestazione intrisa di numerose circostanze contingenti, dalla necessità di assecondare i gusti del popolo all’obbligo di cambiare continuamente argomento e soggetto, al semplice bisogno di guadagnare e sopravvivere facendo l’artista. È così che nasce l’improvvisazione, e da lì tutto lo sviluppo successivo dell’arte drammatica moderna”.
L’idioma di Lindaro
Ma che cos’hanno di speciale i personaggi di questa ‘Moscheta’ furbacchiona che attirano anche oggi?
“La commedia del Ruzzante e la riduzione di Lučić possiedono quel non so che di gioioso, di gaudente, quell’eros, quella passione che tutto ispira e tutto muove, la gioia del gioco: i personaggi sono così divertenti e tuttavia così reali, per cui è come se parlassero di noi stessi o se parlassimo noi stessi. Uomini e donne del Ruzzante sono uomini e donne in carne ed ossa, sono umani fino all’esasperazione, sicché l’attore stesso rende meglio il personaggio che più gli appartiene come carattere, e sceglierà sempre d’interpretare un personaggio di questa fatta, un marginale, piuttosto che l’impenetrabile nobile che non offre alcun ‘gancio’ a cui aggrapparsi, come diciamo noi in gergo. Poi c’è l’argomento: l’amore, la passione, l’adulterio, la fregatura. E c’è il fattore sorpresa, per non parlare della lingua, che è un personaggio a sé stante.
Quando mettemmo in scena ‘Furbaćona 1’, la lingua di Lindaro fu una scoperta rivoluzionaria, tutti eravamo entusiasti di questo eccezionale ritrovamento linguistico, non si parlava che del vernacolo quasi estinto del villaggio di Lučić, mentre oggi quel dialetto è considerato uno standard, ha ottenuto la sua legittimità, il che è importante. Bisogna dire che in Croazia solo il Teatro di Pola e quello di Varaždin curano e cullano il repertorio dialettale con metodo e lungimiranza, nessun’altra compagnia di prosa assolve a questa funzione con continuità e dedizione, ma solo occasionalmente, di passaggio, se capita”.
Che non è la stessa cosa.
“E no. Poi naturalmente ci capita di dover affrontare ogni volta da capo le elucubrazioni dei soliti scettici, dei dubitatori di professione che continuano a svalutare il dialetto, e non vedono il motivo per cui aggiungere infiorettature inutili a quanto la lingua letteraria è capace di esprimere benissimo per sé stessa. Ma le cose stanno diversamente. La lingua della commedia è il dialetto. La stessa cosa detta in dialetto ha tutto un altro sapore: acquista musicalità, spirito, umorismo, vita. Però è necessario attingere ai classici per un motivo molto semplice: non abbiamo il diritto di ‘sbagliare’. Uno spettacolo in dialetto dev’essere giustificato mille volte. Ovvio che i signori della schiatta dei Glambay non possono parlare in dialetto: sarebbe assurdo. Ma a far parlare in dialetto qualunque personaggio del Goldoni ci si guadagna immensamente. Personalmente vorrei cimentarmi in testi dialettali moderni, ma se ne vedono pochissimi in circolazione. Milan Rakovac sta facendo degli sforzi in tal senso, vedremo cosa ne verrà fuori. ‘Riva i druxi’ è stato un successo, ora vedremo cosa avrà da offrire di nuovo. La chiave del successo è forse una giusta proporzione tra classico e moderno, tra criteri artistici universali e spunti o argomenti locali. Chissà forse un musical istriano dialettale, un giorno… Comunque bisogna distinguere tra scrittori e attori dialettali, perché la produzione letteraria e una compagnia di prosa che sia capace a mantenere una scena teatrale in dialetto, non sono la stessa cosa. Ci sono scrittori, certamente, ci sono tentativi di riduzioni teatrali moderne, ma pochi punti di contatto e l’esito è ancora alquanto incerto”.
La differenza sta nel finale
Intanto “Furbaćona” è in scena da 11 anni, e siamo decisamente fuori dai ranghi.
“‘Furbaćona 1’ è andata in scena per la prima volta nel 2008, ed è rimasta in cartellone fino all’estate del 2013. È stata rappresentata parecchio ma non eccessivamente, credo che abbia avuto sulle 35 repliche, mentre ‘Furbaćona 2’ è in scena dalla scorsa estate e finora abbiamo avuto una quindicina di rappresentazioni, con l’ultima a Parenzo, alla rassegna ‘Zlatni zub’ (Il dente d’oro, nda), che ci è valsa il secondo premio, e la prossima a Spalato in occasione del Festival ‘Marulovi dani’ (Le giornate di Marulo, nda.). A proposito della partecipazione al Festival di Spalato, ce ne facciamo un vanto perché è la prima volta che il Teatro di Pola ‘esporta’ in terra di Dalmazia una pièce di questo genere e questo tono. Certo, c’eravamo stati anche in altre occasioni, ma sempre con spettacoli pertinenti al tema, mentre ‘Furbaćona’ è diversa in tutto e per tutto. D’altra parte vorrei aggiungere che tra la prima e la seconda versione vi è una differenza di non poco conto, perché cambia inavvertitamente l’epilogo delle vicende, il finale”.
Caspita! Allora bisogna tornare a teatro per rivederla. Ora che ci penso, ricordo che anche a suo tempo a proposito del finale diceva che “manca il lieto fine”. Come diavolo manca un lieto fine in una commedia? È una contraddizione in termini.
“Il lieto fine manca nel senso che la partita è terminata ma la battaglia dura perché l’esito è sempre e comunque una sorta di pareggio. Voglio dire, i nodi intrecciati sono stati provvisoriamente slegati, ma i ruoli e le posizioni fondamentali rimangono quelli che sono, e così gli antagonismi. Lei si riferisce alle mie parole della locandina, e ricordo d’averle scritte, è vero, ma oggi direi diversamente: non è che non ci sia un lieto fine, è che manca una soluzione definitiva. Il dramma ha il suo bell’elemento di catarsi, di purificazione, nella commedia c’è la risata liberatoria, l’epilogo, il sollievo. Da che parte andrà Furbaćona, a chi si legherà, è secondario. Ma questo è il canone della commedia: la relazione adulterina e l’intreccio costruito intorno alla possibilità del sesso di tutti con tutti. Oggi naturalmente siamo più liberi di un tempo e quello che in passato è stato di per sé fonte di scandalo e riso (il solo accenno al sesso) oggi è manifesto, esplicito, niente affatto dissimulato. Se in passato il sipario calava prima della ‘fruizione dei corpi’, oggi questo pudore apparirebbe ridicolo e bisogna escogitare quel modo di rappresentare il sesso in scena senza naturalmente farlo vedere sul serio. Nel Rinascimento la sola idea che potrebbe nascere un qualcosa di amoroso e di adulterino era sufficiente per alimentare risate a crepapelle, oggi di questa pudicizia, che sia stata vera o meno, ce ne facciamo delle beffe, e andiamo ad escogitare soluzioni umoristiche diverse. Per fare questo tipo di teatro leggiadro che piace occorre enfatizzare questo momento erotico che è il sale di ogni commedia che si rispetti. La nostra Marjuča è furba e marcia professando la propria onestà e dignità di donna, ma poi si fa i calcoli che meglio le convengono e cerca il suo posticino sotto il sole come ogni donna e uomo su questa terra”.
Ci sono più donne o uomini nel pubblico, confessi.
“Ci sono più donne, sicuramente. È evidente che il pubblico è preponderantemente femminile. Ma non è solo il caso di
‘Furbaćona’ o di commedie che rientrano nel genere. In platea il pubblico è sempre in maggioranza femminile, e rari sono gli spettacoli in cui si raggiunge la parità dei sessi, quel 50-50 p.c. che sarebbe lo specchio fedele della società. Invece uno spettacolo per soli uomini è fuori discussione. Per averne uno dovrebbe essere quanto meno una festa di addio al celibato, una di quelle senza veli. Ma vede, questa non è una specificità del territorio, è piuttosto una costante. In qualsiasi teatro del mondo si assiste alla stessa disparità di genere, quindi direi che siamo nella media. Poi si capisce che per intrattenimento l’uomo intenda soprattutto lo sport, anche se poi s’accontenta di una banalissima ubriacatura al bar dietro l’angolo, mentre la donna con la sua sensibilità chiede altro. Non ho mai indagato la sociologia del pubblico, ma ora che ci penso mi sembra che le cose stiano precisamente in questi termini, e che il fenomeno – anche questo – sia globale”.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.